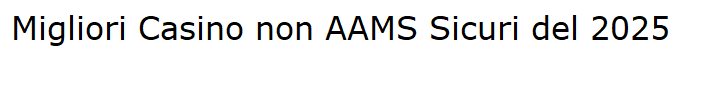Genyornis newtoni è stato l’ultimo dei grandi mihirung (“uccelli del tuono”) incapaci di volare endemici dell’Australia. Era un uccello di corporatura robusta, alto più di 2 metri, con ali minuscole e zampe posteriori massicce. Fossili di Genyornis sono stati trovati in associazione con manufatti umani, comprese pitture rupestri e impronte scolpite. L’esemplare deve aver coesistito con gli umani per un periodo di tempo considerevole (almeno 15.000 anni).

Nuovi studi sul Genyornis newtoni
Gli scienziati conoscono da tempo il Genyornis newtoni. La specie, che si è estinta circa 45.000 anni fa, fu descritta per la prima volta nel 1913. Si tratta di un uccello imponente alto fino a 2,25 metri e pesante fino a 230 chilogrammi, ed è stato una presenza interessante negli habitat erbosi che preferiva, in una vasta fascia del continente australiano.

Una nuova scoperta tuttavia ha indicato che l’esistenza di questo imponente esemplare potrebbe essere stata interpretata male. Un team di paleontologi ha infatti scoperto un cranio quasi completo e articolato di Genyornis newtoni. È solo il secondo teschio che sia stato mai trovato per questa specie. Il primo è stato utilizzato per la descrizione della specie del 1913.
La ricerca
Per la prima volta, è possibile davvero osservare bene il cranio dell’animale che è caratterizzato da peculiarità molto interessanti. Il fossile ha rivelato che Genyornis si sarebbe davvero distinto in mezzo alla fauna, apparendo molto diverso da altri uccelli strettamente imparentati.
Annuncio pubblicitario
Interessato all'Intelligenza Artificiale?
Prova a leggere su Amazon Unlimited la nostra guida su come installarne una in locale e come ricavarne il massimo.
Una Intelligenza Artificiale locale ti permette di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'uso dell'IA ma senza dover pagare costosi abbonamenti.
📘 Leggi la guida su AmazonEra provvisto di una scatola cranica di notevoli dimensioni, grandi mascelle e una cresta ossea triangolare chiamata casque sul cranio. In effetti, alcune caratteristiche del cranio di Genyornis newtoni erano coerenti non con i suoi parenti più stretti, ma con i primi lignaggi di uccelli acquatici divergenti all’epoca.
Il suo becco era simile a quello degli uccelli che vediamo intorno a noi oggi, come l’oca gazza australiana ( Anseranas semipalmata ).
” Genyornis newtoni aveva una mascella superiore alta e mobile come quella di un pappagallo ma a forma di oca, un’ampia apertura, una forte forza di morso e la capacità di schiacciare piante e frutti morbidi sul palato”, ha spiegato la paleontologa Phoebe McInerney della Flinders University in Australia.
“Le esatte relazioni di Genyornis all’interno di questo gruppo sono state complicate da comprendere, tuttavia, con questo nuovo cranio abbiamo iniziato a mettere insieme i pezzi del puzzle che mostra, in poche parole, che questa specie è un’oca gigante“.
I ricercatori hanno eseguito scansioni del fossile e sono stati in grado di creare una ricostruzione tridimensionale dettagliata. Questa ricostruzione ha permesso il confronto con i teschi di altri uccelli viventi, per scoprire come avrebbe funzionato la testa di Genyornis e che aspetto avrebbe potuto avere.

“La forma di un osso e le strutture su di esso sono in parte legate ai tessuti molli che interagiscono con essi, come muscoli e legamenti, e ai loro siti o passaggi di attacco“, ha affermato il paleontologo Jacob Blokland della Flinders University.
“Utilizzando gli uccelli moderni come comparativi, siamo in grado di ridare struttura muscolare ai fossili e riportarli in vita“.
La struttura del suo orecchio era tale che il canale sarebbe stato protetto dall’acqua quando Genyornis newtoni ne avesse immerso la testa, e la struttura del becco offriva la stessa protezione per la gola. La forma del becco sembra che sarebbe stata utile anche nell’afferrare e strappare le piante acquatiche.
Se così fosse, potrebbe aiutare a spiegare perché il Genyornis newtoni si è estinto, dal momento che gli habitat di acqua dolce in cui avrebbe prosperato sono diventati salati, alterando drasticamente l’ecosistema.
Conclusioni
Probabilmente si potranno avere più informazioni solo attraverso un’analisi più attenta e, si spera, trovando più fossili, ma è interessante conoscere finalmente la vera identità di questa straordinaria specie.
La ricerca è stata pubblicata su Historical Biology.