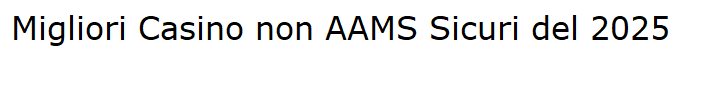Il nome di Ettore Grande alla maggior parte di noi non dice niente, e invece nel periodo che va dal 1938 al 1951 era su tutti i giornali come protagonista di uno degli affaires criminali più misteriosi di quei tempi.

Ettore Grande era piemontese, nato nel 1903 in una modesta famiglia, e fin da ragazzo aveva sempre dovuto lottare per affermarsi e raggiungere la sua meta: la carriera diplomatica.
Aveva studiato a forza di borse di studio e finalmente era riuscito ad entrare in diplomazia, prima a Berlino poi a Tunisi, a Valona in Albania e infine a Charleroi, in Belgio. Fu proprio nell’estate del 1938 che Ettore ricevette la tanto desiderata nomina a Primo Segretario della legazione italiana a Bangkok: una posizione prestigiosa.
Insieme con la nomina, però, gli giunse anche un caldo invito a sposarsi prima di partire. Il regime fascista non vedeva di buon occhio gli scapoli; la lontananza dall’Italia, il divieto di allacciare relazioni con le donne indigene, potevano pregiudicare la sua permanenza nel regno del Siam. Ettore, quindi, si rivolse agli amici e uno di loro gli organizzò un incontro al Caffè Baratti di Torino con Vincenzina Virando.

Vincenzina, detta in famiglia Nina, aveva 25 anni, era figlia di un importante gioielliere torinese, era graziosa, alta e bionda, e munita di ben un milione di dote (nel 1938). I due giovani si piacquero e decisero quasi subito di sposarsi; dopo soli due mesi di fidanzamento, in cui le loro relazioni si limitarono a passeggiate al Valentino e serate in famiglia, il matrimonio fu celebrato il 31 luglio del 1938. Dopo il ricevimento gli sposi partirono per Venezia, da cui si sarebbero poi imbarcati per l’Oriente.

I primi giorni, a dar retta alle lettere che Vincenzina scriveva ad amici e parenti, furono felici: lei viveva al Lido l’esistenza brillante ed elegante che aveva sempre desiderato, e anche quando si imbarcarono sul Conte Rosso la ragazza fu entusiasta della vita di bordo.
Bastarono però poche settimane di navigazione a farle cambiare completamente umore. L’Italia si allontanava sempre di più, e forse l’accordo tra gli sposi, sostanzialmente due estranei, non era proprio così perfetto come Ettore dava ad intendere nelle sue lettere. Nina cominciò a trovare tutto noioso e antipatico: le città erano calde e sporche, i panorami non la entusiasmavano più.

I due arrivarono a Bangkok il 27 agosto 1938: dapprima si stabilirono all’Hotel Oriental, il migliore della città, e fecero la conoscenza con la colonia occidentale. I coniugi Grande parteciparono a parecchi ricevimenti, ma mentre Ettore conosceva bene le lingue e poteva quindi conversare con tutti, Nina parlava soltanto l’italiano e poche parole di francese; la maggior parte delle invitate era composta di signore inglesi e olandesi, e lei dopo qualche frase di convenienza che Ettore le aveva insegnato, rimaneva lì nella penosa situazione di chi finge di seguire una conversazione e non ne capisce neppure una parola.
Neanche la casa che Ettore Grande scelse per la loro abitazione riuscì a sollevarla dalla depressione che cominciava a impadronirsi di lei: era una villa di otto stanze, con giardino, dotata di molti confort e popolata di ben sette domestici cinesi che le facevano quasi paura per la loro capacità di apparire silenziosamente all’improvviso. La mobilia era stata scelta dal marito, lei non se ne era interessata, e si limitò a disporre negli armadi il suo guardaroba fatto di modelli esclusivi delle prime sartorie di Torino, che a causa del clima non poteva indossare e restavano lì a sbiadire per l’umidità altissima. Aveva addirittura portato una pelliccia di ermellino.

Venne il ventitré novembre 1938. Verso le sei del mattino Ettore si alzò, andò a farsi la doccia e, mentre si radeva, gli parve di udire uno strano rumore provenire dalla camera: corse e vide la moglie, coricata a letto con la testa penzoloni, il mento e il collo imbrattati di sangue, che si dibatteva gemendo.
Grande si precipitò da lei, cercò di fermare l’emorragia, poi chiamò il maggiordomo cinese e lo mandò a chiamare un dottore che arrivò poco dopo. Era un ebreo tedesco di nome Gotschlich, già conosciuto da Ettore, che esaminò la donna e si rivolse al marito mormorando: “Non c’è più niente da fare, bisogna chiamare la polizia”.
Ettore Grande fu interrogato. Si trattava di suicidio? La pistola era la sua, che teneva nel comodino, nascondiglio conosciuto benissimo anche da Nina; Grande disse che durante la sua assenza dalla camera, qualche minuto dopo la prima detonazione, ne aveva sentita un’altra, sparata a distanza. Ma Gotschlich stesso, che aveva riscontrato l’esistenza di due sole ferite, una di ingresso l’altra di uscita del proiettile, gli aveva detto che era impossibile, di non insistere nel pensare che Vincenzina avesse potuto ripetere il suo gesto e che si trattava senz’altro di un’allucinazione.
La polizia siamese aveva provveduto a interrogare i servitori venendo a conoscenza di circostanze che, per chiarezza, possono essere riassunte così: il maggiordomo e l’uomo di fatica percepiscono due detonazioni; a sua volta e presumibilmente nello stesso istante, la lavandaia ne percepisce una sola. Circa dieci minuti dopo echeggiano due nuovi colpi e questa volta le deposizioni risultano concordi, li hanno uditi la lavandaia, l’uomo di fatica e un terzo servitore sopraggiunto.
Il maggiore Pombejara, capo della polizia di Bangkok, stese il suo rapporto conclusivo sull’inchiesta dove affermò che “stante la dichiarazione dei testimoni la conclusione potrebbe non essere quella di suicidio”.
A Torino, intanto, la famiglia Virando era stata avvertita e partì il 7 dicembre, imbarcandosi sul Conte Rosso. Giunti a Singapore una sorpresa li attendeva: al pontile di sbarco si trovava Ettore che aveva lasciato Bangkok con la salma imbalsamata della moglie senza attendere l’arrivo del cognato e dei suoceri. Si era disfatto della casa, dei servi che aveva licenziato senza una lira di mancia, e di una parte dei mobili. Aveva disposto le cose in modo di raggiungere Singapore in tempo per partire con il Conte Biancamano.
La famiglia Virando cominciò a sospettare che la figlia non si fosse in realtà suicidata. Il 27 gennaio 1939 approdarono a Venezia: quattro giorni dopo l’autorità giudiziaria concesse il permesso dell’autopsia, che rivelò la gravidanza di Nina.
I risultati si presentarono in contrasto con le precedenti dichiarazioni del dottor Gotschlich. La perizia di Torino rivelava che le ferite distribuite attorno al collo di Vincenzina erano sei, e così disposte: una ferita al lato destro del collo; una alla parte anteriore e una al lato sinistro in alto; un’altra, sempre al lato sinistro del collo ma un po’ più in basso. Finalmente una ferita al mento e una alla nuca.
Da questo totale di sei ferite i periti traevano la conclusione, secondo la direzione dei proiettili, che gli spari erano stati quattro, e precisamente: un proiettile entrato dalla ferita che si trovava al lato destro del collo e usciva dal lato sinistro dello stesso; un altro entrato dalla parte anteriore del collo e uscito dalla ferita situata un poco più in basso dell’altro; le altre due ferite, al mento e alla nuca, erano a fondo cieco, e cioè i proiettili erano ancora conficcati nel cadavere.
Dalla ferita al mento il proiettile, attraverso la lingua e il palato, era andato a spezzare il midollo spinale, producendo istantaneamente una lesione mortale. Quanto alla ferita alla nuca, verosimilmente doveva trattarsi dell’ultima, a causa della scarsa infiltrazione dei tessuti.
Questi rilievi facevano naturalmente scartare l’ipotesi del suicidio e avvaloravano, al contrario, quella dell’omicidio, a cui faceva pensare anche il numero dei colpi sparati in direzioni diverse e in parti insolite per i suicidi, l’impossibilità per Vincenzina di potersi sparare un colpo alla nuca dalla parte sinistra, non essendo mancina.
Rimanevano così due sole soluzioni possibili: che Nina fosse stata uccisa da suo marito oppure da una terza persona; ma quest’ultima eventualità non venne mai presa in considerazione seriamente né dalla polizia siamese né dalla magistratura di Torino. Prima di tutto Ettore stesso l’aveva sempre escluso, in secondo luogo bisognava ammettere che l’assassino conoscesse il luogo dove si trovava la rivoltella e spiegasse perché si era servito di essa.
Così si ritenne che ci fossero elementi sufficienti per ammettere l’uxoricidio.

Il diplomatico venne tradotto in questura, dove gli fu comunicato l’ordine di arresto, e di lì condotto alle Carceri Nuove. Grande scrisse un messaggio alla famiglia, nel quale diceva che non avrebbe voluto rimanere “più di un’ora in quel luogo”. Ci rimase invece sette anni.
Ettore rimase in segregazione cellulare per centocinquanta giorni, sottoposto a interminabili interrogatori. Grande cadde spesso in gravi e incomprensibili contraddizioni.
Aveva detto, per esempio, che quando si trovava nella stanza da bagno, a otto o dieci metri dal letto in cui Nina si trovava, aveva inteso gli spari mentre stava lavandosi, poi disse che stava radendosi, che era sotto la doccia e infine che si stava asciugando. Anche sul periodo di tempo da lui trascorso nella stanza da bagno dopo aver udito il primo colpo era stato impreciso, e aveva detto dapprima che si trattava di una mezz’ora, poi di un quarto d’ora e infine di pochi minuti addirittura.
Furono interrogati, durante l’inchiesta, duecentosettantacinque testimoni. Le deposizioni degli italiani che risiedevano nel Siam al momento della tragedia non furono sempre unilaterali: il ministro e il personale della legazione interpretarono i fatti a favore del suicidio, gli altri connazionali a favore dell’omicidio.
“È enorme”, scrisse Ettore in una lettera, “che si possa dubitare che io abbia ucciso mia moglie, io che l’ho amata, io che ho fatto un mondo di spese per lei, indebitandomi con mio padre di circa centomila lire, consumando tutti i miei risparmi per questo matrimonio, per mettere su la casa, per fare un lussuoso viaggio, per offrirle tutti i conforti. Io che l’ho onorata in morte affrontando anche spese eccessive, io che ho perduto, con la sua morte, anche i vantaggi economici della dote e della forte eredità che le sarebbe spettata alla morte del padre”. Più che della moglie, morta a soli venticinque anni, sembrava che gli importasse dei soldi.
Dopo due anni di istruttoria il magistrato trasmise gli atti al procuratore generale della corte d’assise di Torino. Il processo si svolse ai primi d’aprile nel 1941 ed ebbe scarsa risonanza perché i giornali, secondo le leggi di allora, non se ne poterono occupare.
I risultati delle perizie ebbero un peso determinante, la teoria della ferita alla nuca come foro di uscita non venne presa seriamente in considerazione. Il procuratore generale, di fronte all’ostacolo di trovare un movente all’azione di Grande, disse che non lui ma Ettore stesso lo avrebbe dovuto spiegare.
Ettore venne così condannato, l’undici aprile, a ventiquattro anni di reclusione per uxoricidio.
Grande rimase a Torino alle carceri Nuove fino al 1942. A causa dei bombardamenti i prigionieri delle Nuove vennero smistati, e lui fu assegnato alla casa di pena di Fossano. Nel ’43, cominciò un periodo avventuroso. Diede la sua opera alla Resistenza favorendo l’evasione di prigionieri politici e di partigiani; contemporaneamente, per la sua conoscenza del tedesco, fu di prezioso aiuto per i dirigenti della casa durante i frequenti contrasti con le autorità germaniche.
A liberazione avvenuta, ricominciò a sperare nell’immediato svolgimento del secondo processo: infatti fin dal 1943 la corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di Torino e rinviato l’imputato a nuovo giudizio.
Il processo venne fissato a Novara per i primi d’ottobre del 1946.
La Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di Torino per due motivi: prima di tutto non era sembrata sufficientemente giustificata l’esclusione dell’ipotesi del suicidio. In secondo luogo quella conclusione, piuttosto sbrigativa, di considerare la ferita alla nuca come foro d’uscita non era apparsa chiaramente giustificabile.
Nei documenti del ricorso, da parte dei legali di Ettore, c’era una breve relazione che, pur non avendo carattere ufficiale, aveva notevolmente influito sulle decisioni della Cassazione. Erano tre sole pagine dattiloscritte in cui il professor Uffreduzzi, direttore della clinica chirurgica dell’Università di Torino, aveva spontaneamente esposto le sue opinioni sugli errori commessi dai periti giudiziari.
Uffreduzzi aveva prestato la sua opera disinteressatamente e, quando egli morì, il professor Pierantonio Gagna, suo discepolo, mise nel difendere l’imputato una passione così efficace da farlo diventare il personaggio più importante di tutto il processo. Egli fu, se non il creatore, per lo meno il divulgatore della tesi della ricerca dell’apofisi odontoidea (il dente dell’epistrofeo) che finì per diventare l’epicentro del secondo dibattimento.

In sostanza, la ricerca del dente dell’epistrofeo (che ha sede nella cavità dell’atlante, su cui posa il capo), poneva questa duplice tesi: o il frammento osseo si trovava nell’interno del cranio e ne conseguiva che vi era stato lanciato dal proiettile stesso, o non vi si trovava, e ne conseguiva che il dente rimosso dalla sua sede da uno dei tre colpi, e divenuto esso stesso proiettile, aveva provocato il famoso foro alla nuca. Fu anche dimostrato che il rumore dei primi colpi, che Ettore diceva di non aver sentito, avrebbe potuto essere stato soffocato dal fatto che Vincenzina si era sparata premendo la canna della pistola contro di sé.
Si disse che a Novara, oltre al professore Gagna, fu l’avvocato Delitala a salvare Ettore: l’avvocato difensore intuì, nella corte e fra i giurati, il cedimento provocato dalle relazioni dei superperiti balistici, radiologici e chirurgici ai quali era stato chiesto di esprimersi sulle tesi contrastanti dei periti d’ufficio e dei consulenti della difesa. Delitala convinse la corte non solo della difficoltà ad ammettere l’omicidio ma andò oltre.
“Un omicidio”, disse Delitala nella sua argomentazione, “con tre ferite al collo in una zona ristrettissima, è assolutamente un non senso, perché quelle ferite presuppongono un’assoluta immobilità della vittima e un omicida che con inumana freddezza calcoli ogni volta la direzione dell’arma. Il primo colpo, che non è stato sicuramente mortale, avrebbe certamente determinato un movimento difensivo, il secondo non avrebbe quindi colpito la vittima nella stessa zona con tramiti uniformi”.
“Il numero dei colpi”, continuò Delitala, “non prova l’impossibilità del suicidio. Se il primo colpo lede un organo vitale manca la possibilità del secondo, ma se il primo colpo non lede nessun organo vitale è più frequente che il suicida reiteri il colpo o desista? Meno frequenti sono invece i suicidi con più colpi, sparati con qualche intervallo di tempo, ma neppure essi sono una rarità”. E citò il caso di un ingegnere di Torino che, sparatosi nella propria abitazione, venne trasportato moribondo all’ospedale, dove tentò di ripetere l’atto suicida.
Al termine del dibattimento Ettore, richiesto se aveva qualcosa da dire, rispose: “Credo che Dio illuminerà i giudici”.
La sentenza di Novara sembrò tener conto delle conclusioni di Delitala, e nelle motivazioni si legge: “Non è inverosimile che la Virando, già depressa fisicamente per effetto del clima e della gravidanza, possa, in un momento di grande depressione, aver ceduto all’impulso suicida”.
Ettore fu assolto per insufficienza di prove e tornò dopo otto anni di assenza presso la famiglia dei genitori, che con la guerra si erano trasferiti al loro paese d’origine, Villafranca Piemonte. “Se avessi potuto”, disse Ettore ai giornalisti che si recarono a intervistarlo, “avrei voluto rimanere in carcere, perché un’assoluzione per insufficienza di prove non soddisfa quel desiderio di giustizia che io chiedo da dieci anni, che è l’unica cosa ancora cui io aspiro e che costituisce ormai l’unica ragione della mia vita”.
Ricorse perciò in Cassazione e ricorse pure il pubblico ministero, e il caso Grande, come una palla rilanciata, tornò nuovamente al punto dov’era partito: ma questa volta il giudizio di Roma riuscì alquanto diverso dal precedente: anche la sentenza di Novara venne cassata, e la salma della povera Nina fu nuovamente riesumata ed esaminata.
Il processo definitivo si celebrò a Bologna nel 1951.

L’aria sembrò subito più calma che nel Piemonte del 1941 o del 1946. Invecchiando, gli animi si erano moderati: Grande non polemizzò coi Virando, i Virando gli augurarono di provare la sua innocenza e le facce degli avvocati erano più distese.
Ettore Grande fu assolto con formula piena e portato in trionfo dai suoi sostenitori.
Nel 1952 rientrò in diplomazia a Roma come vice caposervizio dell’ufficio stranieri in una dipendenza di Palazzo Chigi, all’interno di Villa Borghese, un incarico che gli servì a riprendere contatto con l’ambiente.
Finalmente, alla fine del 1954, il ministero destinò Ettore Grande a Sofia, con funzioni di primo segretario. La capitale bulgara non era per lui una sede ideale: fu tuttavia lì che Ettore incontrò una giovane donna bulgara, Varvara Racheeva. Benché lui avesse ormai 52 anni e lei soltanto 27, tra i due nacque una simpatia che si trasformò presto in un affetto profondo.

Quando Grande fu trasferito a Bengasi come console generale, Varvara chiese un visto turistico per la Turchia e riuscì a farsi riconoscere, in quel Paese, lo status di rifugiata politica; qui Ettore la raggiunse e la portò con sé in Libia, riuscendo finalmente a celebrare il matrimonio nel 1958.
Ma non era destino, evidentemente, che Ettore Grande potesse godere di una vita tranquilla: come risulta da Wikipedia, nel 1961 Varvara tentò il suicidio. Ettore fu trasferito in Brasile e la moglie chiese e ottenne il divorzio.
Ettore Grande finì la sua carriera in Italia andando in pensione nel 1971: morì a Pescara nel 1992, all’età di 89 anni.
Il misterioso caso di Ettore Grande
Il nome di Ettore Grande alla maggior parte di noi non dice niente, e invece nel periodo che va dal 1938 al 1951 era su tutti i giornali come protagonista di uno degli affaires criminali più misteriosi di quei tempi.
Indice