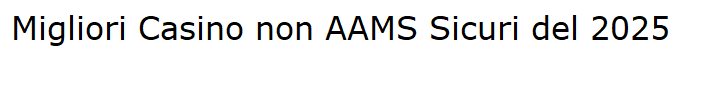Una tempesta solare rappresenta un fenomeno naturale potenzialmente perturbanti, capaci di compromettere le nostre infrastrutture tecnologiche, causare interruzioni nell’erogazione di energia elettrica e persino esercitare effetti diretti sugli organismi viventi.
Le recenti scoperte di un team di ricercatori rivelano un evento di radiazione di portata inimmaginabile, un picco di intensità compatibile con un evento di particelle solari estreme (ESPE) che surclassa qualsiasi fenomeno precedentemente documentato, sia attraverso osservazioni dirette che nella memoria storica.

Tempesta solare estrema: una radiazione senza precedenti registrata nel passato
L’evento solare più intenso mai registrato strumentalmente risale al 20 gennaio 2005. Un individuo che si fosse trovato a bordo di un aeromobile sopra le regioni polari meridionali durante tale tempesta (aree particolarmente esposte alla radiazione) avrebbe ricevuto in una sola ora la dose annuale tipica di radiazione cosmica a livello del mare. Le nuove stime proiettano un’intensità ancora maggiore per un evento avvenuto nel 12350 a.C.: in meno di otto secondi, un ipotetico viaggiatore aereo si sarebbe trovato esposto alla dose annuale di radiazione.
La dott.ssa Kseniia Golubenko, autrice principale dello studio presso l’Università di Oulu in Finlandia, ha dichiarato che, secondo le loro stime, l’antico evento del 12350 a.C. è stato oltre 500 volte più intenso della più potente tempesta di particelle registrata nell’era satellitare moderna, quella del 2005. Il celebre evento di Carrington, pur essendo la tempesta solare più potente mai osservata direttamente, non fu accompagnato da una significativa tempesta di particelle solari, rendendo difficile un confronto diretto. Un altro punto di riferimento cruciale per questa ricerca è l’evento del 775 d.C., anch’esso di notevole potenza.
Le prove di entrambi gli eventi provengono dall’analisi degli anelli degli alberi, ma per l’evento più remoto nel tempo, i ricercatori hanno dovuto affrontare la complessità di stimare la crescita degli anelli in condizioni climatiche glaciali.
Oltre le tempeste solari ordinarie: l’ipotesi dei super-brillamenti
La nostra comprensione dell’attività solare e dei suoi impatti sul sistema Terra si concentra primariamente sulle tempeste solari “ordinarie“, fenomeni energetici che, pur potendo causare significative perturbazioni geomagnetiche e tecnologiche, rientrano in un intervallo di intensità relativamente contenuto. Tuttavia, alcuni modelli teorici, basati sull’osservazione di stelle simili al nostro Sole, suggeriscono la possibilità che la nostra stella madre sia in grado di generare eventi di energia enormemente superiore, i cosiddetti super-brillamenti.
Annuncio pubblicitario
Interessato all'Intelligenza Artificiale?
Prova a leggere su Amazon Unlimited la nostra guida su come installarne una in locale e come ricavarne il massimo.
Una Intelligenza Artificiale locale ti permette di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'uso dell'IA ma senza dover pagare costosi abbonamenti.
📘 Leggi la guida su AmazonQuesti fenomeni ipotetici, con un tasso di occorrenza stimato, secondo alcuni modelli iniziali e semplificati, di circa uno ogni 6.000 anni, rappresenterebbero un ordine di grandezza di energia rilasciata significativamente maggiore rispetto alle più potenti tempeste solari finora registrate.
La scoperta di eventi di radiazione solare estrema avvenuti nel lontano passato, come quello del 12350 a.C. e quello del 775 d.C., solleva un interrogativo cruciale: potrebbero queste anomalie rappresentare le “impronte digitali” di antichi super-brillamenti solari? L’intensità senza precedenti stimata per l’evento del 12350 a.C., centinaia di volte superiore alla più potente tempesta solare dell’era moderna, suggerisce una fonte di energia straordinaria, potenzialmente riconducibile a un super-brillamento. Analogamente, l’evento del 775 d.C., pur essendo meno intenso, si distingue per la sua anomala concentrazione di isotopi radioattivi negli anelli degli alberi, un segnale che potrebbe essere compatibile con l’impatto di un’intensa radiazione solare.
È fondamentale sottolineare che l’associazione diretta tra questi eventi preistorici e l’ipotesi dei super-brillamenti solari rimane al momento speculativa. I modelli teorici che predicono la frequenza dei super-brillamenti sul Sole sono ancora in fase iniziale di sviluppo e si basano su analogie con altre stelle, la cui attività magnetica e i meccanismi di rilascio energetico potrebbero differire significativamente dal nostro Sole. Inoltre, l’interpretazione delle tracce indirette di questi eventi antichi, come le anomalie negli anelli degli alberi, richiede modelli geochimici e climatici estremamente sofisticati per escludere altre possibili cause.
La conferma dell’esistenza di super-brillamenti solari nel passato del nostro sistema stellare avrebbe implicazioni profonde per la nostra civiltà tecnologica, sempre più dipendente da infrastrutture sensibili alle perturbazioni elettromagnetiche. Un evento di tale portata potrebbe causare danni catastrofici ai satelliti, alle reti elettriche, ai sistemi di comunicazione e a innumerevoli altri dispositivi elettronici, con conseguenze potenzialmente devastanti per la società globale.
Pertanto, è imperativo intensificare la ricerca in questo campo, sviluppando modelli più accurati dell’attività solare, analizzando in dettaglio le tracce di eventi passati e valutando il reale rischio di futuri super-brillamenti. Solo attraverso una comprensione approfondita di questi fenomeni estremi potremo sperare di mitigarne gli eventuali impatti.
L’evento del 12350 a.C.: un nuovo scenario di rischio per le infrastrutture tecnologiche moderne
L’affermazione della dott.ssa Golubenko sottolinea un punto cruciale: la scoperta di un evento di particelle solari estreme (ESPE) di intensità senza precedenti, come quello verificatosi nel 12350 a.C., non rappresenta una mera curiosità paleoclimatica o astrofisica. Al contrario, esso delinea un “nuovo scenario peggiore” nel contesto dei potenziali impatti dell’attività solare sulla nostra civiltà tecnologica. Comprendere appieno la portata e le caratteristiche di un evento di tale magnitudine diventa un imperativo per una valutazione accurata dei rischi che future tempeste solari, anche se di intensità inferiore, potrebbero rappresentare per le infrastrutture moderne che sorreggono la nostra società.
La nostra dipendenza da sistemi tecnologici sofisticati e interconnessi ci rende intrinsecamente vulnerabili alle perturbazioni di origine spaziale. Satelliti, essenziali per le comunicazioni globali, la navigazione, l’osservazione terrestre e la sicurezza, operano in un ambiente esposto al flusso di particelle cariche e alle intense radiazioni emesse durante le eruzioni solari.
Le reti elettriche, che alimentano le nostre città e industrie, sono suscettibili a correnti indotte geomagneticamente (GIC) causate dalle variazioni rapide del campo magnetico terrestre innescate dalle tempeste solari, con il potenziale di danneggiare trasformatori e causare blackout su vasta scala. I sistemi di comunicazione, dalle reti internet ai sistemi radio, possono subire interruzioni a causa del disturbo ionosferico provocato dall’aumento del flusso di raggi X e radiazione ultravioletta durante gli eventi solari.
L’intensità stimata dell’evento del 12350 a.C., centinaia di volte superiore alla più potente tempesta solare registrata in epoca strumentale, fornisce un nuovo punto di riferimento per valutare la vulnerabilità delle nostre infrastrutture. Se un evento di tale portata dovesse ripetersi nell’era moderna, le conseguenze sarebbero potenzialmente catastrofiche. I satelliti potrebbero subire danni irreparabili ai loro componenti elettronici, rendendoli inutilizzabili.
Le reti elettriche, esposte a correnti indotte di intensità senza precedenti, potrebbero collassare su scala continentale, con blackout prolungati e danni ingenti alle apparecchiature. I sistemi di comunicazione globali subirebbero interruzioni estese, paralizzando le attività economiche, i servizi di emergenza e le interazioni sociali.
Comprendere la possibilità di eventi solari estremi, come quello del 12350 a.C., impone un cambio di prospettiva nella nostra valutazione del rischio spaziale. Non possiamo più limitarci a considerare solo gli impatti delle tempeste solari di intensità “storica“. L’eco di un evento solare avvenuto oltre 14 millenni fa risuona con un monito per la nostra società contemporanea. L’evento del 12350 a.C. non è solo un reperto scientifico, ma un campanello d’allarme che ci spinge a riconoscere la vulnerabilità delle nostre infrastrutture tecnologiche di fronte alla potenza del Sole e a intraprendere azioni concrete per proteggerle da future tempeste, anche quelle di intensità inimmaginabile.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Earth and Planetary Science Letters.