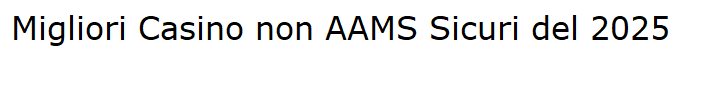di Fabiana Lanzi
A Roma non ci vivo solamente, io Roma la vivo ogni giorno, da cittadina e da pendolare. Con l’affanno di chi sa cosa significa spostarsi con i mezzi pubblici di questa città che, da Capitale, si sta trasformando sempre più a periferia dell’impero.
A Roma corri e ti indigni.
Corri perché se perdi il treno sai che il prossimo vale, minimo, dai trenta ai quaranta minuti di attesa.
Corri perché, se sul tuo tragitto hai bisogno del bus numero 53 – l’autobus fantasma, così lo chiamano – e per una manciata di minuti lo perdi, serve un bel segno della croce e una buona dose di pazienza prima di vederne un altro.

Si corre a Roma, ci si indigna, anche per acquistare il biglietto alle macchinette automatiche, dove infili i tuoi due euro e, puntualmente, non funzionano e ti rubano i soldi e allora corri dagli addetti al controllo e: “Signorì, che je potemo fa, chiami il servizio clienti” ( a cui non risponde nessuno ) e riprendi la tua corsa, con due euro in meno nelle tasche. Correndo, con lo sguardo doppio tipico di ogni romano, che sta attento alla strada, agli incroci, al suv che sbuca a cento all’ora da una rampa e così attraversi una babilonia dal cielo azzurro.
Annuncio pubblicitario
Interessato all'Intelligenza Artificiale?
Prova a leggere su Amazon Unlimited la nostra guida su come installarne una in locale e come ricavarne il massimo.
Una Intelligenza Artificiale locale ti permette di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'uso dell'IA ma senza dover pagare costosi abbonamenti.
📘 Leggi la guida su AmazonArrivi alla prima stazione della metropolitana e quello che c’è da fare sono scale e scalini, e non mi riferisco a quelle di Regina Coeli, un tempo dimostrazione di verace romanità per ogni malandrino, né a quelle che ci portano fin sopra la cupola di San Pietro. Parlo degli scalini delle scale mobili che, in due stazioni su tre, non sono funzionanti e quando finalmente raggiungi le seggiole arancioni della linea A ti accorgi di quanto questa città sia lontana dal famoso “panem et circenses”- Addio panem ma, addio pure circenses, direi – perché, oltre ai mezzi pubblici fantasma e mal funzionanti, oltre l’indignazione quotidiana, oltre le tristezze dell’ultimo Natale (ricordate l’albero comatoso di Piazza Venezia e piazza Navona vuota?) basta fare una passeggiata a Ponte Milvio.

Basta scendere alla fermata Flaminio e prendere il tram 2, per trovarsi davanti Piazza di ponte Milvio, la famosa piazza del libro di Moccia, dove sono spariti all’improvviso i tavolini, tutti. Persino le modeste e casuali sedie del bar Pallotta senza obbligo di consumazione. E’ un caso piccolo ma molto simbolico per chi in città ci vive. E’ il racconto di come si può trasformare la Capitale (in peggio) pur seguendo alla lettera le regole. Si, a Ponte Milvio sedie e tavolini sono scomparsi perché il municipio ha fatto il nuovo piano di occupabilità del suolo, e in attesa che i bar aggiornino le domande e gli uffici rispondano, invece di prorogare le vecchie autorizzazioni ha deciso di fare tabula rasa. In punta di diritto, nulla da eccepire. E’ un modo come un altro di agire, un modo super legale. Però, sicuri che migliori le cose togliendo alla città anche lo sfizio di un aperitivo seduti?
Lo stesso è stato fatto a Capocotta ( il “mare gratis” dei romani) con i chioschi ritenuti fuori norma, tutto sigillato in attesa di nuovi bandi, che però non sono mai arrivati.
Star senza panem e senza circenses è senza dubbio una novità per Roma, dove il lavoro ha stentato sempre ma la qualità della vita, il divertimento e il relax con pochi spicci, interclassista e casuale, non è mai mancato.
Se ne va Sky, chiude Almaviva, scappano quelli del progetto Torri, tornano le voci di un trasloco Mediaset dalla storica sede del Palatino, è in dubbio la costruzione del nuovo stadio. Cose che capitano all’improvviso, tutte insieme, senza un minimo comune denominatore, ma che trasmettono ai romani lo stesso messaggio: Roma sta perdendo gli ultimi brandelli di fascino e prestigio.
Quel che mi domando è se l’invocazione delle regole in questa città si sta trasformando nell’ideologia dell’immobilismo, del non fare per non sbagliare.
Con questa domanda continuo il mio tour sui mezzi ATAC, che per colpa di manager o semplici autisti, hanno contribuito con i loro comportamenti a diffondere il credo che “ATAC” non sia un acronimo, ma la prima parte dell’espressione tutta romana “attaccatevearcazzo”. E sono tanti i retroscena da raccontare e i luoghi in cui il degrado e l’immobilismo fanno da padroni, così tanti che bisogna scegliere un luogo simbolico da dove cominciare:

Via Libero Leonardi-Cinecittà Est, ad esempio. Due fermate di bus oltre il capolinea della metro. Estrema periferia. Cemento popolare e borghesia impoverita, parcheggi arroventati, tre parchetti di erbacce secche e panchine arrugginite.
I figli della periferia corrono tra aiuole sterrate e altalene sbilenche. Tra cestini stracolmi e cespugli pieni di rifiuti.
Nessun privilegio, tutta Roma è così.
E’ così la stazione Termini, che di sera si trasforma in un dormitorio a cielo aperto, una città dentro la città. Un doppio volto. Se di giorno è il crocevia di viaggiatori e pendolari, al tramonto attraversare Via Marsala, Via Giolitti, Piazza dei Cinquecento, Via Amendola vuol dire essere catapultati in una realtà da terzo mondo.
Io continuo a correre, a vivere e amare questa città, a cui cerco di dare un’immagine fortemente rappresentativa ogni volta che mi trovo davanti a situazioni e disagi quotidiani. Provo con il Colosseo, così da comprendere in un baleno tutta la storia di Roma imperiale, potenza e crudeltà, magnificenza e sangue. Con la Cupola di San Pietro, che con le sue curve armoniose ci racconta la Roma papale e rinascimentale, arte, solennità, spiritualità e opulenza. Ma nessuna di queste immagini riesce ad annodare in un attimo i fili sparsi e spezzati di questo preciso periodo.
A mio avviso, la torre trasparente delle Smart che si erge sul bordo del Raccordo ha la giusta potenza simbolica e imbattibile per la Roma di oggi. Ogni volta che passo davanti a quella vetrina verticale, a quei sette piani di cristallo dove come giocattoli stanno esposte le celebri micro vetture, mi sembra di sentire il soffio dei nostri giorni.
Vanità e leggerezza, superbia e tecnologia, infantilismo e edonismo, ansia e paralisi, ricchezza e dure scadenze rateali, speranza e depressione: tutto si concentra in quella torre di Babele che sfida l’azzurro del cielo.
E’ il monumento della nostra epoca ambiziosa e fragile, che vorrebbe andare lontano ma resta bloccato dietro un vetro.