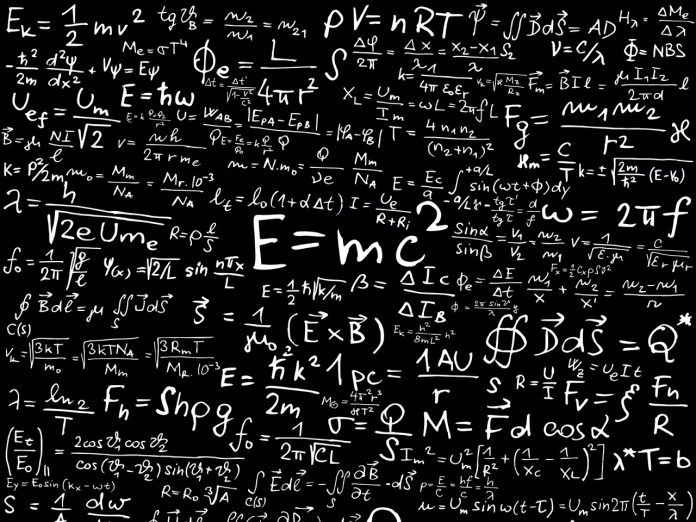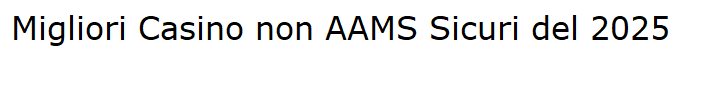È passato più di un secolo dal periodo di boom della fisica con Albert Einstein, Max Planck e altri, che ci hanno catapultato in un nuovo mondo di caos, sconvolgendo l’ordine che, in precedenza, credevamo governasse l’universo. Questa brillante generazione di fisici rivoluzionò la nostra visione dell’universo, così come dell’atomo, per rivelare un mondo strano oltre la fantasia.
La teoria del tutto
Fin dagli albori della meccanica quantistica, la teoria che governa il micromondo degli atomi e delle particelle, la fisica è andata alla ricerca del Santo Graal della fisica, una teoria del tutto in grado di unire la meccanica quantistica con la teoria della relatività generale di Einstein che, invece, si applica all’universo su larga scala.
Il fatto che a più di un secolo di distanza non abbiamo ancora una teoria collaudata in grado di spiegare tutto probabilmente dipende, almeno in parte, dalla paura del fallimento.
Creare una teoria del tutto non è esattamente facile. Si tratta di produrre una struttura che unisca le forze fondamentali del nostro universo, tenendo conto di tutte le costanti e quantità sottostanti, nonché di ogni particella subatomica. Il premio per chi risponderà a questa domanda fondamentale sarà la gloria eterna negli annali dell’umanità.
La generazione di Einstein lavorò alacremente a questo problema. In effetti, Einstein stesso lavorò a una teoria del tutto fino alla morte, un lavoro per il quale alla fine fu ridicolizzato. Il contributo di Einstein alla fisica è stato così grande che rimane ancora una superstar. Ma i fisici Arthur Eddington, Hermann Weyl e il matematico David Hilbert non furono così fortunati, e alcuni di loro dovettero affrontare conseguenze molto peggiori.
Prendiamo Eddington, ad esempio, forse il più grande scienziato di cui non si ricorda più quasi nessuno. L’astronomo e fisico di Cambridge dimostrò che Einstein aveva ragione nel suo lavoro analizzando un’eclissi del 1919, lanciando Einstein verso la celebrità. Eddington scrisse anche i primi libri inglesi sulla relatività prima di fare lo stesso sulla teoria del Big Bang di Georges Lemaître.
Annuncio pubblicitario
Interessato all'Intelligenza Artificiale?
Prova a leggere su Amazon Unlimited la nostra guida su come installarne una in locale e come ricavarne il massimo.
Una Intelligenza Artificiale locale ti permette di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'uso dell'IA ma senza dover pagare costosi abbonamenti.
📘 Leggi la guida su AmazonScrisse anche un libro sulla fisica quantistica e divenne il più grande scrittore popolare di scienza negli anni ’20 e ’30, insieme al suo lavoro rivoluzionario sulla fisica stellare (la fisica delle stelle). Eppure oggi è stato in gran parte dimenticato, proprio a causa della sua intensa ricerca di una teoria fondamentale.
Pubblicato postumo, il suo tentativo venne subito bandito per il suo incredibile fallimento. Deriso per la numerologia (la credenza in una relazione mistica tra un numero e gli eventi) e il suo strano interesse per il potere di certi numeri fu preso in giro da altri scienziati e, come hanno sottolineato molti importanti astrofisici, non ha prodotto alcun valore dalla sua pubblicazione.
Lo straordinario fallimento finale di Eddington è servito da potente avvertimento sul prezzo che si paga se si manca l’obiettivo. Gli ultimi dieci anni della sua vita, trascorsi a perseguire una teoria del tutto, si conclusero con un grave danno alla sua eredità.
Una nuova generazione
La generazione del fisico Richard Feynman (1918-1988), successiva a quella di Einstein ed Eddington, perse interesse per una teoria del tutto. Feynman e i suoi colleghi trovarono la loro gloria nelle nuove scoperte e teorie subatomiche e nelle applicazioni della fisica alla chimica e alla biologia, che portarono a numerosi premi Nobel. Il ridicolo sopportato da coloro che provarono e fallito prima di loro potrebbe essere stato uno dei motivi.
Questo costo eccessivo per il fallimento alla fine aumentò insieme alla gloria della fisica tra le due guerre. In un periodo di successi senza precedenti, il fallimento fu più implacabile. Questo non fu certo un incentivo per le menti moderne giovani e brillanti che cercavano di applicarsi alla questione più grande.
Ancora oggi i tentativi di trovare teorie del tutto vengono derisi. La teoria delle stringhe, ad esempio, è un tentativo di questo tipo ma è stata rapidamente disprezzata dal premio Nobel Roger Penrose tacciandola di non essere vera scienza.
Non è solo. Il fisico Stephen Hawking credeva che una versione della teoria delle stringhe chiamata teoria M fosse la nostra migliore opzione per una teoria del tutto. Ma la teoria ha faticato a produrre previsioni che possano essere verificate mediante esperimenti.
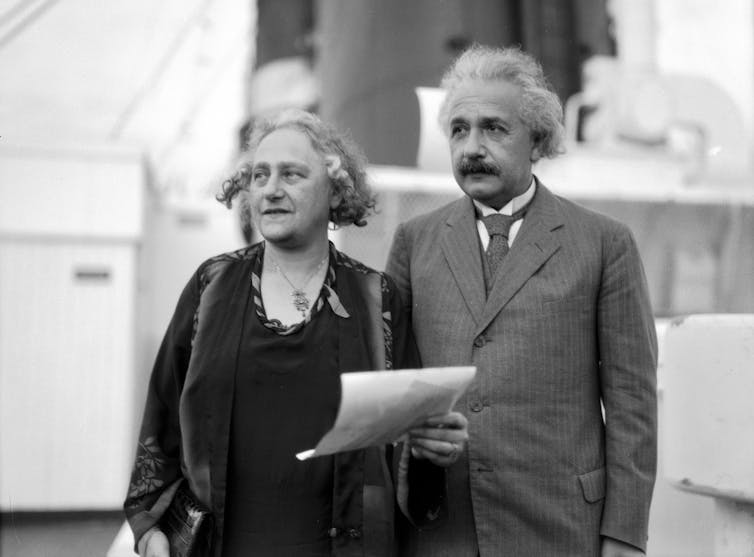
Un giovane scienziato oggi potrebbe chiedersi: se Einstein, Eddington e Hawking non sono riusciti a risolvere il problema, chi lo farà? In effetti, molti dubitano che questo problema possa essere risolto. C’ addirittura chi si chiede se potremo farne a meno.
Non c’è da meravigliarsi, quindi, che oggigiorno molti fisici preferiscano evitare il termine “teoria del tutto”, optando invece per alternative meno grandiose come “gravità quantistica”.
Finanziamenti e progressione di carriera
Oltre al pesante prezzo del fallimento, altri problemi sono in agguato. Una giovane mente brillante potrebbe trovarsi di fronte a un vicolo cieco nella sua carriera nel cercare una teoria del tutto. Quale progressione accademica ci si può aspettare all’inizio della propria carriera se ci si imbarcasse in una ricerca simile? Chi darebbe finanziamenti significativi a ricercatori giovani e non esperti che perseguono un obiettivo apparentemente impossibile a breve termine?
È probabile che una teoria del tutto alla fine richieda una massiccia collaborazione per essere risolta. Ironicamente, questo potrebbe essere un compito riservato ai fisici più anziani, nonostante gli avvertimenti di Eddington e altri. Francis Crick dedicò la sua attenzione nel tentativo di risolvere il problema della coscienza nei suoi ultimi anni, anche se senza successo.
Abbiamo bisogno di collaborazione. Purtroppo, però, potremmo guardare alla prospettiva d’elaborazione di una teoria del tutto solo da scienziati avanti nella carriera, che avranno realizzato così tanto da potersi permettere di affrontare il potenziale imbarazzo godendo del beneficio del dubbio. una situazione che difficilmente entusiasmerà menti giovani e vivaci che altrimenti potrebbero affrontare il problema.
Nel tentativo di risolvere il problema finale, potremmo aver inavvertitamente creato un mostro. Il nostro quadro accademico per la progressione della ricerca non è favorevole a ciò, e la storia ha presentato un quadro poco positivo di ciò che accade a coloro che ci provano.
Eppure, il nostro progresso più grande è sempre arrivato da coloro che si sono mostrati disposti a correre dei rischi.