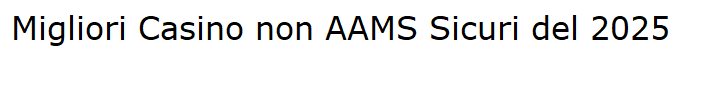I paleontologi del Manitoba Museum e del Royal Ontario Museum (ROM) hanno annunciato la straordinaria scoperta di un nuovo predatore risalente a 506 milioni di anni fa, i cui resti fossili sono stati rinvenuti nel celebre giacimento di Burgess Shale, in Canada.
Denominato Mosura fentoni, questo organismo di dimensioni contenute, paragonabili a quelle di un dito indice, presentava una morfologia peculiare e inattesa.

Mosura fentoni: un insolito radiodonte con addome segmentato e branchie
Tra le sue caratteristiche distintive spiccavano tre occhi, artigli spinosi e articolati atti alla predazione, una bocca circolare dotata di denti affilati e un corpo allungato con alette natatorie disposte lungo i fianchi. L’insieme di queste peculiarità anatomiche ha permesso di ascrivere Mosura al gruppo estinto dei radiodonti, un clade di antichi artropodi che comprendeva anche il noto Anomalocaris canadensis, un temibile predatore di circa un metro di lunghezza che condivideva gli stessi ambienti acquatici di Mosura nel Cambriano medio.
Nonostante le affinità con gli altri radiodonti, Mosura fentoni possedeva una singolare caratteristica morfologica mai osservata in nessun altro membro di questo gruppo: una regione corporea posteriore, simile a un addome, composta da una serie di segmenti distinti.
In particolare, Mosura presentava ben sedici segmenti strettamente compatti nella parte terminale del corpo, ciascuno dei quali era dotato di branchie. Come ha evidenziato Joe Moysiuk, curatore di paleontologia e geologia presso il Manitoba Museum e principale autore dello studio, questa segmentazione addominale con organi respiratori rappresenta un notevole esempio di convergenza evolutiva con gruppi di organismi moderni, quali i limuli, gli onischi e gli insetti, che condividono una simile organizzazione segmentale nella parte posteriore del corpo dedicata alla respirazione.
La ragione evolutiva di questo adattamento unico in Mosura fentoni rimane ancora oggetto di indagine. Tuttavia, i ricercatori ipotizzano che la segmentazione addominale con branchie potesse essere correlata a specifiche preferenze ambientali o a particolari comportamenti di Mosura che richiedevano una respirazione più efficiente rispetto agli altri radiodonti. Grazie alle ampie appendici natatorie situate nella regione mediana del corpo e all’addome stretto e segmentato, era stata informalmente soprannominata “falena di mare” dai paleontologi durante le fasi di raccolta sul campo, in riferimento alla sua vaga somiglianza con una falena. Questa suggestiva analogia ha infine ispirato il suo nome scientifico: un omaggio al celebre kaiju giapponese immaginario noto come Mothra.
Annuncio pubblicitario
Interessato all'Intelligenza Artificiale?
Prova a leggere su Amazon Unlimited la nostra guida su come installarne una in locale e come ricavarne il massimo.
Una Intelligenza Artificiale locale ti permette di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'uso dell'IA ma senza dover pagare costosi abbonamenti.
📘 Leggi la guida su AmazonInformazioni chiave sui tratti ancestrali degli artropodi
Sebbene il suo soprannome popolare di “falena di mare” possa suggerire una parentela con le vere falene, Mosura fentoni appartiene in realtà a un ramo evolutivo molto più antico e distante nell’albero della vita degli artropodi, il vasto e diversificato gruppo di animali che comprende anche ragni, granchi e millepiedi. Questa posizione filogenetica basale conferisce a Mosura un’importanza cruciale per comprendere le origini e la diversificazione precoce di questo phylum di successo.
Come ha sottolineato Jean-Bernard Caron, coautore dello studio e curatore di paleontologia degli invertebrati presso il ROM: “I radiodonti sono stati il primo gruppo di artropodi a ramificarsi nell’albero evolutivo, quindi forniscono informazioni chiave sui tratti ancestrali dell’intero gruppo. La nuova specie sottolinea che questi primi artropodi erano già sorprendentemente diversi e si stavano adattando in modo simile ai loro lontani parenti moderni“. La scoperta di Mosura fentoni evidenzia quindi come la diversificazione morfologica e l’adattamento a diverse nicchie ecologiche fossero processi già in atto nelle fasi iniziali dell’evoluzione degli artropodi.
Un aspetto particolarmente straordinario dei numerosi fossili di Mosura ritrovati è la conservazione di dettagli significativi dell’anatomia interna dell’organismo, inclusi elementi riconducibili al sistema nervoso, al sistema circolatorio e al tratto digerente. Questa eccezionale preservazione di tessuti molli offre una finestra unica sulla biologia di questi antichi predatori. Come ha aggiunto Caron: “Pochissimi siti fossili al mondo offrono questo livello di comprensione dell’anatomia interna molle. Possiamo osservare tracce che rappresentano fasci di nervi negli occhi, che sarebbero stati coinvolti nell’elaborazione delle immagini, proprio come negli artropodi viventi. I dettagli sono sbalorditivi“.
Contrariamente al sistema circolatorio “chiuso” presente nei vertebrati, inclusi gli esseri umani, caratterizzato da arterie e vene distinte, Mosura fentoni possedeva un sistema circolatorio “aperto“. In questo tipo di sistema, il cuore pompava l’emolinfa (l’equivalente del sangue negli artropodi) in ampie cavità corporee interne denominate lacune. Queste lacune si sono conservate nei fossili come macchie riflettenti che riempiono il corpo dell’animale e si estendono fin dentro le sue alette natatorie, offrendo un’ulteriore testimonianza della straordinaria qualità di conservazione dei fossili del Burgess Shale.
Una ricca collezione di fossili di Mosura e le nuove aree di scavo
Come ha evidenziato Joe Moysiuk, curatore del Manitoba Museum e ricercatore associato al ROM, le lacune ben conservate del sistema circolatorio di Mosura ci aiutano a interpretare caratteristiche simili, ma meno chiare, che abbiamo già osservato in altri fossili. La loro identità è stata a lungo oggetto di dibattito. Questa eccezionale preservazione in Mosura fentoni fornisce quindi un modello di riferimento cruciale per decifrare le anatomie interne di altri organismi cambriani, la cui interpretazione è stata finora incerta. Moysiuk ha inoltre sottolineato la portata di questa scoperta: “Risulta che la conservazione di queste strutture è diffusa, il che conferma l’antica origine di questo tipo di sistema circolatorio ‘aperto’ negli artropodi primordiali“.
Dei sessantuno fossili di Mosura analizzati nello studio, la quasi totalità (sessanta esemplari) è stata meticolosamente raccolta dal ROM tra il 1975 e il 2022, principalmente nella celebre cava di Raymond situata all’interno del Parco Nazionale di Yoho, nella Columbia Britannica. Alcuni esemplari di Mosura provengono anche da nuove aree di scavo nei dintorni di Marble Canyon, localizzato nel Parco Nazionale di Kootenay, circa quaranta chilometri a sud-est.
Queste nuove aree si sono rivelate un vero e proprio tesoro di spettacolari fossili del Burgess Shale, portando alla luce anche altri radiodonti di notevole interesse scientifico, tra cui Stanleycaris, Cambroraster e Titanokorys. Un esemplare inedito di Mosura, raccolto dal pioniere dello studio del Burgess Shale, Charles Walcott, è stato anch’esso incluso nella ricerca, arricchendo ulteriormente la comprensione di questa straordinaria creatura.
Con un’affermazione che sottolinea l’importanza fondamentale del patrimonio paleontologico conservato, Moysiuk ha dichiarato: “Le collezioni museali, vecchie e nuove, sono un tesoro inesauribile di informazioni sul passato. Se pensi di aver già visto tutto, ti basta aprire un cassetto del museo“. I siti fossiliferi del Burgess Shale, incastonati all’interno dei parchi nazionali di Yoho e Kootenay, sono gestiti con grande cura da Parks Canada.
Questa agenzia governativa canadese è orgogliosa di collaborare attivamente con importanti ricercatori scientifici al fine di espandere la conoscenza e la comprensione di questo periodo cruciale della storia della Terra e di condividere l’importanza di questi siti unici con il resto del mondo attraverso escursioni guidate pluripremiate.
Nel 1980, il Burgess Shale è stato ufficialmente riconosciuto per il suo straordinario valore universale e dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Attualmente, questo sito paleontologico di importanza globale fa parte di un’area protetta ancora più vasta, il sito Patrimonio dell’umanità dei parchi canadesi delle Montagne Rocciose, a testimonianza della sua eccezionale rilevanza scientifica e culturale.
Per coloro che desiderano ammirare da vicino le meraviglie del Burgess Shale, numerosi fossili di radiodonti sono esposti presso la Willner Madge Gallery del ROM, intitolata “Dawn of Life” (L’Alba della Vita), a Toronto. Inoltre, un esemplare di Mosura fentoni sarà esposto per la prima volta al Manitoba Museum di Winnipeg nel corso di quest’anno, offrendo al pubblico un’occasione unica per entrare in contatto con questo straordinario predatore del Cambriano.
Lo studio è stato pubblicato sul Royal Society Open Science.