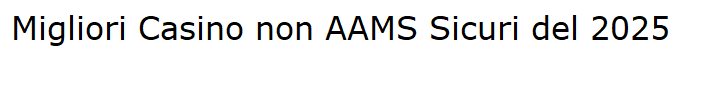Tre chilometri a sud di Lodi la Roggia Bertonica, un canale d’irrigazione largo cinque metri, attraversa la via Emilia e affonda nel verde dei campi, tra alberi e cespugli che lo nascondono alla vista. Appena fuori da Cà de Bolli, frazione del comune di San Martino in Strada, uno sbarramento regola l’alimentazione di alcuni canali secondari formando una cascatella, detta in dialetto tombone.
La mattina di sabato 19 luglio 1958 un contadino vide roteare nel gorgo della cascatella una specie di grosso pacco avvolto in una tovaglia di tela cerata e legato con alcuni giri di spago. A mezzogiorno il pacco era ancora allo stesso punto, sballottato dalla corrente, e alcune donne del posto, incuriosite, decisero di tentare di recuperarlo. Una di loro, con l’aiuto di un falcetto assicurato a una lunga pertica, riuscì a tagliare lo spago: quasi subito una mano cadaverica affiorò tra le pieghe della tela cerata.
Un’ora dopo i carabinieri estraevano dall’acqua i resti di un uomo privo della testa e delle gambe.

Il cadavere era in stato di avanzata decomposizione. Le orribili mutilazioni denotavano la fretta e l’inesperienza di chi le aveva eseguite. Sulla parte superiore del torace, vicino alla spalla, si vedevano tre ferite dovute probabilmente ad un’arma appuntita.
Com’erano finiti quei miseri resti nel canale, e per opera di chi?
A questi drammatici interrogativi tentarono di rispondere i carabinieri e gli agenti della squadra mobile di Milano, impegnati in un’indagine che si delineava come una fra le più difficili registrate fino allora. Il cadavere di Ca’ de Bolli sembrava infatti tolto di peso dalle pagine di un giallo, con la differenza che in questo caso mancavano anche i pochi indizi che gli investigatori hanno a disposizione nei libri e nei film. Nel romanzo Maigret e il corpo senza testa, ad esempio, il celebre commissario parigino ha a disposizione almeno due elementi-base: la probabilità che il corpo sia stato gettato nella Senna poco lontano dal punto in cui l’hanno ripescato e l’assenza sospetta di un abitante del quartiere le cui caratteristiche corrispondono presumibilmente a quelle del morto.
Annuncio pubblicitario
Interessato all'Intelligenza Artificiale?
Prova a leggere su Amazon Unlimited la nostra guida su come installarne una in locale e come ricavarne il massimo.
Una Intelligenza Artificiale locale ti permette di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'uso dell'IA ma senza dover pagare costosi abbonamenti.
📘 Leggi la guida su AmazonNel caso di Ca’ de Bolli invece non c’era nulla: il cadavere non aveva nessun segno particolare; il suo stato rendeva pressoché impossibile ogni tentativo d’identificazione (perfino il rilevamento delle impronte digitali, in parte compromesso dall’azione dell’acqua, non aveva dato riscontri) e, quanto al luogo in cui è stato gettato nel canale, poteva trovarsi in un punto qualsiasi: i sopralluoghi e gli esperimenti eseguiti dai periti dimostrarono che il cadavere avrebbe potuto arrivare a Ca’ de Bolli addirittura dal canale Muzza, ossia da una zona che si estende, a nord di Paullo, fino a Cassano d’Adda.
Gli elenchi delle persone scomparse furono consultati senza trovare nessuna indicazione, anche perché l’età attribuita dai medici all’assassinato (20-25 anni circa) non corrispondeva a quella degli individui la cui scomparsa era stata denunciata di recente.
Gli indumenti del morto avevano qualcosa di contraddittorio: la canottiera, la camicia a scacchi, la cintura, i calzoni lisi e le mutande confezionate in casa erano di infima qualità e facevano pensare a un contadino povero. Invece il pullover indossato dalla vittima era di qualità molto migliore e addirittura non era in vendita in Italia. L’uomo, sempre secondo i periti, poteva averlo acquistato solo di contrabbando, probabilmente da qualcuno della base americana di Livorno. Ma pensare che un povero contadino della Bassa lodigiana fosse andato ad acquistare indumenti di contrabbando fino a Livorno, e soprattutto il fatto che le braccia del cadavere erano indiscutibilmente quelle di un uomo che non aveva mai svolto un lavoro pesante, con le mani regolarmente curate, creava un problema insormontabile.
L’esistenza del pullover permise tuttavia alle Forze dell’Ordine di stabilire uno dei pochi elementi certi: il momento approssimativo in cui avvenne l’omicidio. Il fatto che la vittima indossasse un indumento caldo dimostrava che il delitto doveva essere stato compiuto prima dei giorni di canicola, ossia prima del 10 luglio, ipotesi confermata anche dallo stato di decomposizione del cadavere.
La Roggia Bertonica fu dragata, i fiumi e i canali dei dintorni vennero ispezionati palmo a palmo con l’aiuto di sommozzatori e di vigili del fuoco. I periti analizzarono i resti del cibo – pasta e fagioli e carne in scatola – che la vittima aveva consumato poche ore prima di morire. Le fotografie degli individui scomparsi nelle settimane precedenti furono esaminate a una a una. Centinaia di persone sfilarono davanti alla salma: nessuno la riconobbe.
In realtà i carabinieri arrivarono quasi subito a un passo dalla soluzione del problema, e solo una serie di fatalità impedì loro – come avviene nei “gialli” – di compiere la mossa decisiva. La sera stessa del 19 luglio, infatti, un uomo offrì senza saperlo la chiave del mistero. Era il medico condotto del comune di San Martino in Strada che, incaricato dell’esame preliminare del cadavere, lo descrisse come quello di un uomo sui trentacinque anni, basso, mingherlino, probabilmente zoppo e comunque non avvezzo ai lavori pesanti: se questa descrizione, dettata più dall’intuito che da un’indagine scientifica, non fosse stata modificata dai periti (i quali parlarono addirittura di un ventenne longilineo) l’identificazione della vittima sarebbe avvenuta con relativa facilità.
Tre giorni dopo il ritrovamento, il capitano Cappi, allora comandante della stazione dei carabinieri di Lodi, sentì parlare di un certo Giulio Massaro, che qualche suo conoscente diceva essere scomparso ai primi di luglio, ma le sue caratteristiche fisiche non corrispondevano a quelle elencate dai periti, e la moglie, interrogata, affermò che era vivo e si trovava in Riviera. Quindi la pista fu abbandonata.

Verso la metà di novembre qualcuno propose di archiviare la pratica. Furono il capitano Cappi e il Procuratore della Repubblica dottor Novello a insistere perché si tornasse, come ultimo tentativo, sulla pista del Massaro. Gli elementi di cui disponevano erano scarsi: un paio di lettere anonime, la segnalazione di un suo fratello che ne denunciava la scomparsa, qualche diceria e, soprattutto, la sensazione che le voci intorno al viaggio del ciabattino in Riviera fossero state diffuse ad arte.
Le indagini proseguirono. Come in un gioco di pazienza la vita del Massaro fu ricostruita nei minimi particolari, finché dal quadro generale incominciarono ad affiorare gli elementi del crimine.
Giulio Massaro aveva lasciato nel 1940 Ponte di Brenta, suo paese natale, ed era venuto, appena diciottenne, a cercare fortuna a Milano. La gamba destra, anchilosata dalla poliomielite, lo faceva apparire quasi deforme. Era stato avviato al mestiere di ciabattino, ma lui aspirava a ben altro: amava la musica, sognava le glorie della ribalta. In effetti aveva una bella voce, e fu proprio con la voce che conquistò l’amore dell’unica donna della sua vita: Anna Amazio, una ragazza di Pozzuoli, giunta a Milano nei primi mesi del dopoguerra.
Anna e Giulio si conobbero nel 1945 e si sposarono nel ’47. Lui aveva venticinque anni, lei diciotto. Il viaggio di nozze fu rimandato a data da destinarsi e la vita coniugale iniziò in una stanzetta di via Guicciardini, ceduta da una famiglia di amici. La serenità, purtroppo, durò solo qualche mese: ben presto la miseria incominciò ad avvelenare la vita dei coniugi. Vi furono accuse d’infedeltà, liti, scenate. La nascita del piccolo Riccardo, venuto al mondo nel 1954, non migliorò la situazione.
Nel gelido dicembre del 1956, infine, Anna Amazio decise di lasciare la sua abitazione priva di riscaldamento e di recarsi, con il bambino, a Bresso, in casa del fratello maggiore Vittorio, che aveva abbandonato da pochi mesi la moglie e i due figli per andare a convivere con l’amante. E, proprio a Bresso, Anna incontrò un amico di suo fratello: Luigi Dansi.
In breve si formò un gruppo affiatato. Anna, una giovane graziosa e piena di voglia di vivere e di divertirsi; Luigi Dansi, un uomo collerico, spesso in lite con la moglie; Vittorio Amazio, un eterno disoccupato che riusciva a vivere chissà come, ed era sempre impegolato in storie di donne. Anna e la moglie di Dansi, Fernanda Francesconi, nel febbraio del 1957 furono diffidate dai carabinieri per prostituzione, a cui erano state indotte proprio da Vittorio.

Giulio Massaro, intanto, soffriva. Il suo amore quasi morboso lo spingeva a ignorare le infedeltà della moglie e, nello stesso tempo, lo distruggeva moralmente. I successi ottenuti come cantante ai vari concorsi della “Ugola d’Oro” e del “Microfono d’Oro”, le fotografie che lo ritraevano accanto a Nilla Pizzi e Gino Latilla, non bastavano a sollevargli lo spirito. D’estate si esibiva nelle balere e, talvolta, anche in dancing eleganti (a Riccione, nel 1956, era arrivato a percepire 7.000 lire per sera).
Gli anni precedenti erano stati duri, ora però la situazione era migliorata. Giulio guadagnava qualcosa con il canto e utilizzava il denaro per Anna: aveva comprato un armadio nuovo, una macchina da cucire, una radio: sua moglie, però, aveva altre aspirazioni. Si era trasferita a vivere con Luigi e Fernanda Dansi a San Donato Milanese, in uno stabile decoroso che sembrava una reggia a confronto con la catapecchia di via Conca del Naviglio dove viveva con Giulio, e dove non aveva minimamente voglia di tornare.
A tutta prima Anna si era trasferita a San Donato come domestica di Luigi, ma poi i rapporti fra i due divennero così palesi da costringere la moglie di Dansi, Fernanda, ad abbandonare il tetto coniugale.
Secondo gli inquirenti fu proprio il trasferimento di Anna in casa Dansi, avvenuto in giugno, che diede inizio alla tragedia. Giulio Massaro aveva tollerato tutto pur di continuare a vivere accanto alla donna che amava: ma dopo la partenza di Anna l’uomo incominciò a fare scenate e a profferire minacce. Una sua denuncia provocò un’azione di sorpresa dei carabinieri in casa Dansi: una sua visita a San Donato diede luogo a una lunga lite.
Il 1° luglio Giulio Massaro si recò a San Donato e intimò alla moglie di tornare a casa, senza risultato. Una settimana più tardi, nel pomeriggio del 7 luglio, Fernanda Francesconi se lo vide arrivare a casa in stato di estrema agitazione. “Vado a San Donato a definire una volta per tutte le cose”, le disse. Fernanda cercò di calmarlo e lo invitò a mangiare con lei: pasta e fagioli e carne in scatola. Poco prima delle ventidue Giulio se ne andò: disse che andava a prendere la corriera per San Donato Milanese.
Da quel momento nessuno ricorda di averlo visto. Il suo corpo fu rinvenuto dodici giorni dopo nella roggia Bertonica: in novembre suo fratello Giovanni, giunto da Padova, ne riconobbe gli indumenti.
Secondo l’accusa, quindi, il delitto si sarebbe svolto così: Giulio Massaro sarebbe giunto a San Donato e sarebbe stato ucciso durante un’ennesima scenata. Poi, il suo corpo sezionato forse con l’aiuto di Vittorio Amazio sarebbe finito nelle acque del canale.
Rimanevano tuttavia parecchi interrogativi. Era un delitto premeditato o l’uccisione era avvenuta per caso nel corso di una lite? Chi dei tre fu l’esecutore materiale? Con quale arma fu procurata la morte? Dove si trovavano la testa e le gambe della vittima? E infine, dove avvenne il delitto?
Un’altra domanda importante era questa: dato che davanti alla casa di Luigi Dansi scorreva il canale Redefossi, e dato che a non più di cinque chilometri da San Donato passa il fiume Lambro, come mai i colpevoli preferirono percorrere più di venti chilometri per gettare il cadavere nel Canale Muzza che, a parte la distanza, era più lento e quindi meno “comodo” del fiume?
Nel 1960 vennero rinviati a giudizio Vittorio ed Anna Amazio e Luigi Dansi come colpevoli dell’omicidio e del vilipendio e occultamento del cadavere. L’accusa era gravissima: omicidio premeditato con l’aggravante dei motivi abietti: roba da ergastolo.
Contro i tre c’erano anche le testimonianze di Irene Massaro, nipote del defunto, e di Fernanda Francesconi, che sostenevano di aver udito da Anna Amazio la confessione del delitto. Le due donne, però, che avevano le loro ragioni per detestare la donna, finirono per cadere in gravi contraddizioni e ritrattare.

Vittorio ed Anna Amazio furono quindi assolti per insufficienza di prove, mentre Luigi Dansi, ritenuto l’esecutore materiale del delitto, venne condannato a 22 anni di carcere. Il processo d’appello, celebrato nel 1963, vide l’assoluzione piena per i due fratelli e l’assoluzione per insufficienza di prove per il Dansi, mentre la Cassazione, nel 1967, confermò per quest’ultimo la condanna a 22 anni.
Gli interrogativi sulla misteriosa morte del ciabattino cantante, però, rimasero senza risposta.