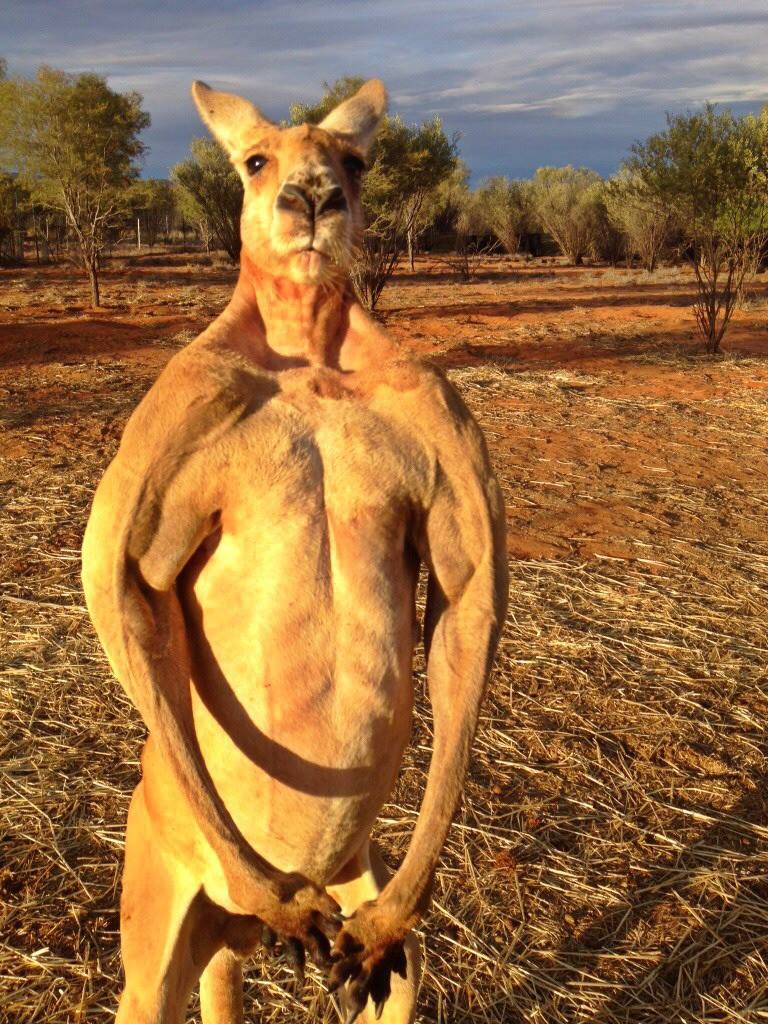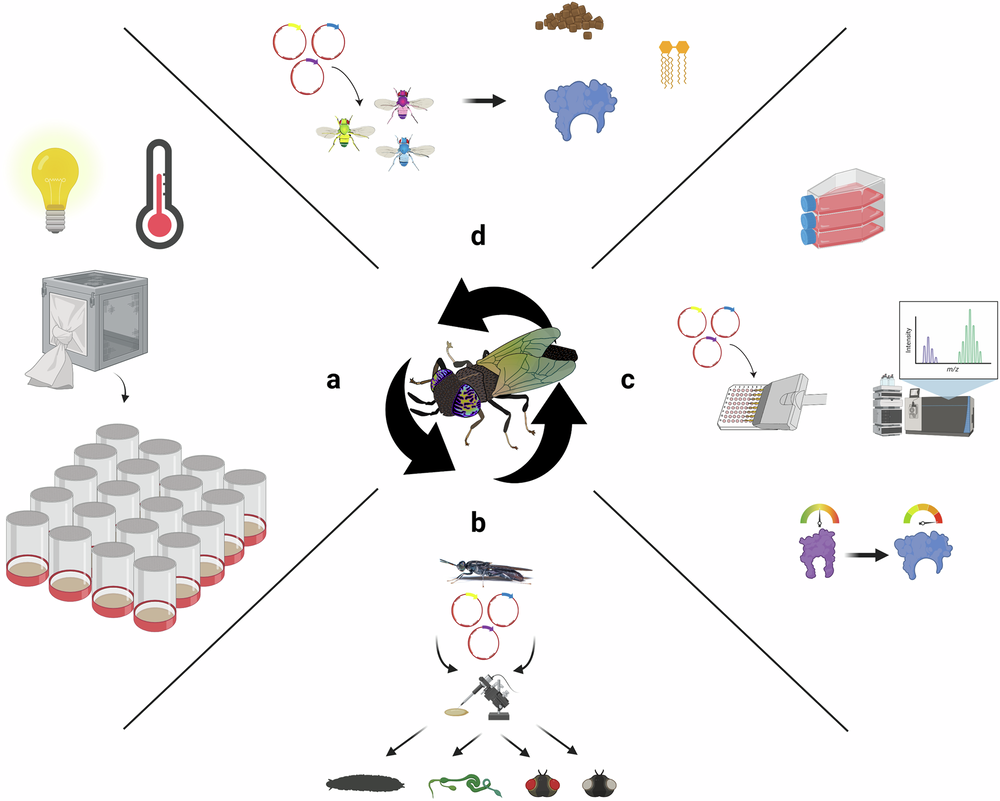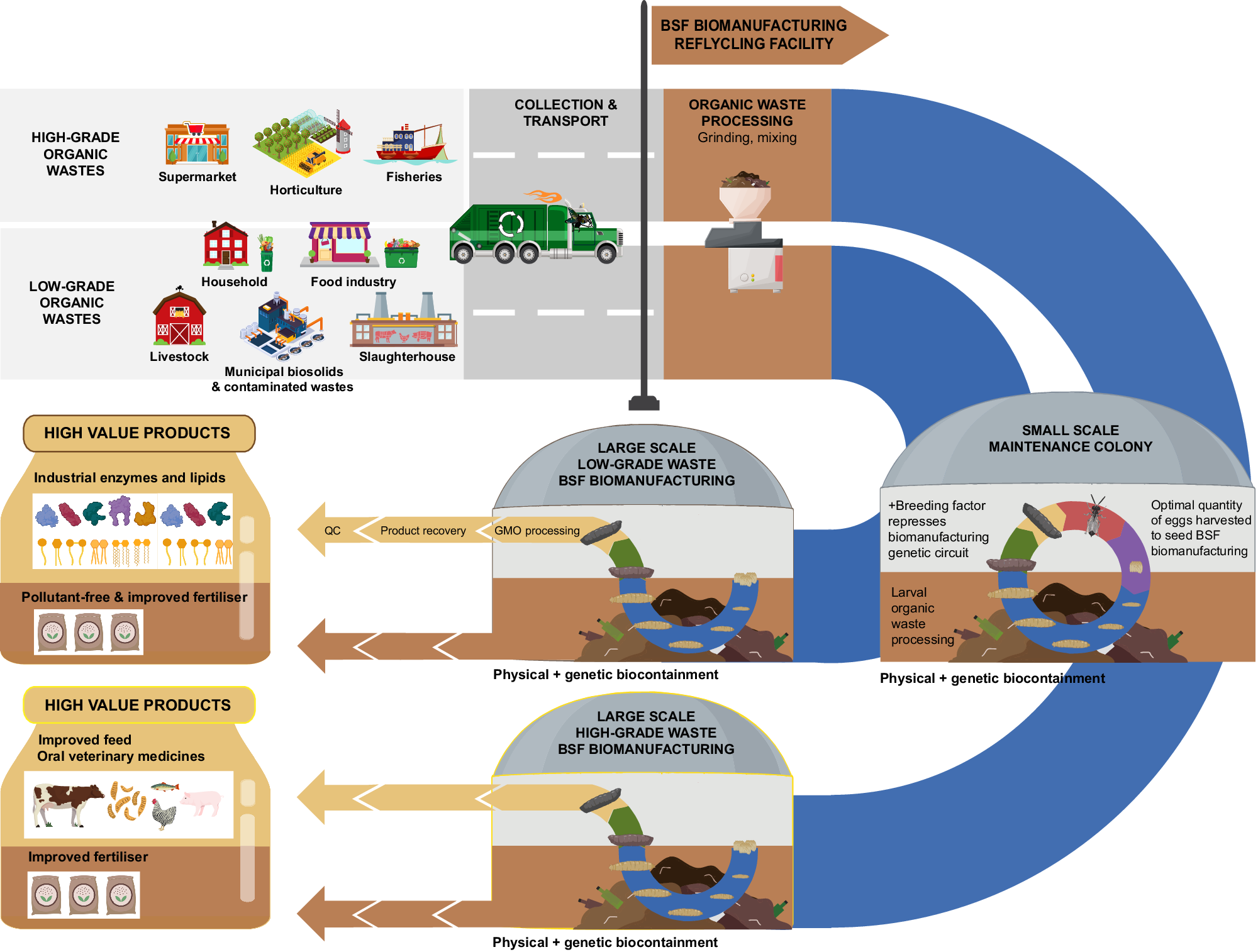Cos’è la demenza?
Demenza è il termine medico usato per indicare un gruppo di malattie neurodegenerative dell’encefalo, tipiche dell’età avanzata (ma non esclusive degli anziani), che comportano la riduzione graduale, e quasi sempre irreversibile, delle facoltà intellettive di una persona.
TIPI DI DEMENZA
I tipi di demenza sono numerosi. Ecco un elenco dei più importanti:
- Morbo di Alzheimer
- Demenza vascolare
- Demenza con corpi di Lewy
- Demenza frontotemporale
- Demenza pugilistica
- Demenza associata ad HIV
- Malattia di Huntington
- Degenerazione corticobasale
- Malattia di Creutzfeldt-Jakob
- Sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker
Alcune lesioni strutturali cerebrali (ad esempio: idrocefalo normoteso, ematoma subdurale), i disturbi metabolici (ipotiroidismo, carenza di vitamina B12) e da sostanze tossiche (piombo) causano un lento deterioramento delle funzioni cognitive che può, però, essere curato con uno specifico trattamento. Questa alterazione è talvolta detta demenza reversibile, ma alcuni esperti restringono il termine demenza esclusivamente a un deterioramento cognitivo irreversibile.
La depressione può mimare la demenza (precedentemente definita pseudodemenza); le 2 patologie spesso coesistono. Tuttavia, la depressione può essere il primo sintomo con cui si manifesta la demenza.
La compromissione della memoria associata all’età si riferisce alle variazioni cognitive che si verificano con l’invecchiamento. Gli anziani hanno una carenza relativa nelle capacità mnesiche, in particolare nella velocità di richiamo dell’informazione, soprattutto se il confronto viene fatto rispetto a quando erano giovani. Questi cambiamenti non influenzano il funzionamento quotidiano e quindi non indicano la demenza. Tuttavia, le prime manifestazioni della demenza sono molto simili.
Il deterioramento cognitivo lieve provoca una maggiore perdita di memoria rispetto alla compromissione della memoria associata all’età; a volte le altre funzioni cognitive e la memoria sono peggiori nei pazienti con questo disturbo rispetto ai controlli di pari età, ma il funzionamento quotidiano non è in genere interessato. Al contrario, la demenza altera il funzionamento quotidiano. Fino al 50% dei pazienti con deterioramento cognitivo lieve sviluppa una demenza entro 3 anni.
Qualsiasi patologia può aggravare i deficit cognitivi nei pazienti affetti da demenza. Il delirium si verifica spesso in pazienti con demenza.
I meccanismi prionici sembrano essere coinvolti nella maggior parte o in tutte le patologie neurodegenerative che si manifestano primariamente negli anziani. Una proteina cellulare normale sporadicamente (o attraverso una mutazione ereditaria) viene ripiegata in maniera anomala in una forma patogena o prione. Il prione agisce quindi come un modello, causando il ripiegamento alterato di altre proteine in modo simile. Questo processo si verifica nel corso degli anni e in molte parti del sistema nervoso centrale.
Molti di questi prioni diventano insolubili e, come l’amiloide, non possono essere facilmente eliminati dalla cellula. Evidenze suggeriscono meccanismi prionici o similari nella malattia di Alzheimer (fortemente), così come nel morbo di Parkinson, nella malattia di Huntington, nella demenza frontotemporale, e nella sclerosi laterale amiotrofica. Questi non sono prioni infettivi come quelli della malattia di Creutzfeldt-Jakob, ma possono essere trasmessi.
La demenza compromette globalmente lo stato cognitivo. L’esordio è graduale, sebbene i familiari possano notare improvvisamente dei deficit. Frequentemente, il primo segno di malattia é la perdita della memoria a breve termine. Inizialmente, i sintomi precoci possono essere indistinguibili da quelli della compromissione della memoria associata all’età o del decadimento cognitivo lieve, ma poi la progressione diventa evidente.
Sintomi di demenza precoci
La memoria a breve termine è alterata; l’apprendimento e la capacità di acquisire nuove informazioni diventano compiti difficili. Si sviluppano problemi di linguaggio (specialmente nella ricerca delle parole), instabilità dell’umore e cambiamenti della personalità. I pazienti possono presentare una progressiva difficoltà nell’effettuare in modo indipendente le attività della vita quotidiana (ricordare gli appuntamenti, ritrovare la strada o ricordare dove hanno messo le cose). Il pensiero astratto, l’insight e la capacità di giudizio sono compromessi. I pazienti possono reagire alla perdita dell’autosufficienza e della memoria con irritabilità, ostilità e agitazione.
L’autonomia funzionale può essere ulteriormente limitata dai seguenti aspetti:
Agnosia: ridotta capacità di identificare gli oggetti nonostante l’integrità delle funzioni sensoriali
Aprassia: ridotta capacità di eseguire compiti motori precedentemente appresi nonostante l’integrità delle funzioni motorie
Afasia: ridotta capacità di comprendere o utilizzare il linguaggio
Nonostante la demenza nelle fasi iniziali possa non compromettere la vita sociale, i familiari possono riferire comportamenti strani associati a labilità emotiva.
Sintomi di demenza intermedi
I pazienti divengono incapaci di apprendere e di ricordare nuove informazioni. La memoria per gli avvenimenti remoti risulta compromessa ma non del tutto persa. I pazienti possono necessitare di aiuto per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana (lavarsi, alimentarsi, vestirsi, fare i propri bisogni).
Le modificazioni di personalità possono progredire. I soggetti possono diventare irritabili, ansiosi, inflessibili, facilmente irascibili o possono diventare più passivi, con un impoverimento affettivo, depressione, indecisione, mancanza di spontaneità o generale abbandono delle relazioni sociali.
Possono svilupparsi disturbi comportamentali: i malati possono vagare o diventare improvvisamente e inappropriatamente agitati, ostili, non collaboranti o fisicamente aggressivi.
Da questo stadio in poi, i pazienti perdono del tutto il senso del tempo e dello spazio, perché non possono utilizzare efficacemente i normali riferimenti ambientali e sociali. I pazienti spesso si perdono; possono non essere in grado di trovare la propria camera da letto o il bagno. Sono deambulanti ma ad aumentato rischio di cadute o di incidenti conseguenti a uno stato confusionale.
Alterazioni sensoriali o percettive possono culminare in psicosi con allucinazioni e deliri paranoidei e di persecuzione.
Il sonno è spesso disorganizzato.
Sintomi di demenza tardivi (gravi)
I pazienti non possono camminare, alimentarsi o svolgere qualsiasi altra attività della vita quotidiana; possono diventare incontinenti. La memoria a breve e quella a lungo termine sono completamente perse. I pazienti possono non essere in grado di deglutire. Sono a rischio di denutrizione, polmoniti (specialmente dovute ad aspirazione) e a ulcere da decubito. Poiché essi dipendono completamente dagli altri per l’assistenza, diventa spesso necessario il ricovero presso una struttura di lungodegenza. Con il tempo, i pazienti diventano muti.
Dal momento che tali pazienti non sono in grado di riferire alcun sintomo al medico e poiché gli anziani spesso, nel corso di infezioni, non hanno febbre o leucocitosi, il medico dovrà basarsi sull’esperienza e sull’intuito ogni qualvolta il paziente possa presentarsi particolarmente sofferente.
Nella fase terminale della demenza sopravvengono il coma e il decesso, generalmente da infezione.
Cause
Le cause di demenza non sono ancora state stabilite con certezza e in modo chiaro. Del resto, l’encefalo umano è una struttura altamente complessa e difficile da studiare.
L’unico dato certo, relativo ai fattori scatenanti, è che qualsiasi tipo di demenza è il risultato di due eventi: la morte delle cellule nervose cerebrali e/o un loro malfunzionamento a livello di comunicazione intercellulare (cioè tra cellula e cellula).
DEMENZA E AGGREGATI PROTEICI NEL CERVELLO
Diverse forme di demenze – tra cui il morbo di Alzheimer, la demenza con corpi di Lewy e la demenza frontotemporale – sono caratterizzate dalla presenza, all’esterno e/o all’interno dei neuroni cerebrali, di anomali aggregati proteici (detti anche inclusioni).
Alcune delle proteine coinvolte in queste anomale formazioni sono la cosiddetta proteina precursore della beta-amiloide (APP), la cosiddetta proteina tau e l’alfa-sinucleina.
- APP forma le placche amiloide; queste si interpongono tra neurone e neurone e sono presenze tipiche del morbo di Alzheimer.
- La proteina tau dà origine ai grovigli neurofibrillari e ad altre strutture simili; questi, a differenza delle placche amiloidi, si sviluppano all’interno dei neuroni (nel citoplasma) e possono rinvenirsi nei malati di Alzheimer, demenza frontotemporale e degenerazione corticobasale.
- L’alfa-sinucleina, infine, genera degli agglomerati insolubili all’interno del citoplasma chiamati corpi di Lewy; quest’ultimi sono caratteristici della demenza con corpi di Lewy, ma si riscontrano anche nelle persone con morbo di Parkinson o atrofia multisistemica.
Nonostante i numerosi studi condotti, i ricercatori non hanno ancora chiarito il meccanismo preciso con cui gli aggregati proteici causano il progressivo deterioramento del tessuto cerebrale interessato. Sanno soltanto che:
- L’esame post-mortem del tessuto cerebrale dei pazienti rivela la presenza di agglomerati anomali.
- Nelle persone cerebralmente sane, APP, tau e alfa-sinucleina non formano agglomerati pericolosi o comunque, se li formano, questi si accrescono molto lentamente e interviene un meccanismo naturale di difesa che li elimina.
Secondo attendibili studi, infatti:
- La demenza vascolare è legata a problemi cerebrovascolari, ovvero a disturbi che impediscono il normale afflusso di sangue nei tessuti del cervello. Del resto, il sangue porta con sé ossigeno e nutrienti, elementi fondamentali per la vita di qualsiasi cellula del corpo.
Alcuni dei problemi cerebrovascolari più influenti sono: la cosiddetta malattia dei piccoli vasi sanguigni, l’aterosclerosi a livello cerebrale e l’ictus. - La malattia di Creutzfeldt-Jacob e la sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker sono connesse al mutamento di una proteina chiamata prione.
Quando anche solo una molecola di prione muta, questa diventa un agente contaminante per tutte le altre, le quali subiscono le medesime alterazioni. Il tutto si conclude con il deterioramento progressivo delle cellule nervose cerebrali. - La malattia di Huntington (detta anche corea di Huntington) insorge a seguito di una mutazione ereditaria a carico del gene che produce la proteina huntingtina. Le persone portatrici di tale mutazione denunciano i primi segni di demenza attorno ai 30-40 anni e possono sopravvivere, prima della morte, per anche 15 anni.
- La demenza pugilistica, nota anche come encefalopatia traumatica cronica, compare successivamente a ripetuti traumi alla testa. È tipica di coloro che un tempo praticavano boxe (ecco da dove deriva il nome), football americano, wrestling o rugby, ovvero tutti sport di contatto durante i quali è frequente ricevere colpi alla testa.
- La demenza associata ad HIV è, come dice il nome, successiva all’infezione da virus dell’AIDS. Questa particolare malattia neurodegenerativa, che riguarda la materia bianca cerebrale, non insorge in tutti i malati di HIV, ma solo in alcuni. Gli studiosi stanno cercando di capire il perché di questo doppio comportamento.
FATTORI DI RISCHIO
I numerosi studi condotti sulle demenze hanno portato all’individuazione di alcuni fattori di rischio.
Un fattore di rischio (o fattore favorente) è una condizione particolare che predispone a un determinato disturbo o malattia, ma che non ne rappresenta propriamente la causa.
Fra i fattori favorenti le demenze, se ne possono riconoscere di modificabili e non modificabili.
Quelli modificabili sono l’ipercolesterolemia (cioè il colesterolo alto), l’aterosclerosi, il fumo di sigaretta, gli elevati livelli di omocisteina nel sangue, l’abuso di alcol e il diabete.
I fattori di rischio non modificabili, invece, sono l’età avanzata, la ricorrenza all’interno della stessa famiglia di una determinata forma di demenza, l’essere affetti da sindrome di Down e il declino cognitivo lieve.
Sintomi e Complicanze
I sintomi e i segni delle demenze variano a seconda della zona di encefalo soggetta a neurodegenerazione. Pertanto, il quadro sintomatologico manifestato da un demente può comprendere un numero elevato di disturbi cognitivi.
Nel complesso, le persone con demenze soffrono di:
- Amnesie. La perdita di memoria è un problema tra i più comuni; rappresenta uno dei primi sintomi che insorgono nei malati di Alzheimer.
- Deficit di concentrazione, pianificazione e ragionamento; lentezza di pensiero. Questi disturbi vengono notati prima dai parenti, i quali si accorgono che il malato non riesce a concentrarsi nemmeno nella lettura di testi molto semplici o a fare semplici calcoli matematici.
- Difficoltà a prendere decisioni e ad eseguire semplici faccende quotidiane (per esempio usare la macchietta del caffè, il forno a microonde ecc).
- Sbalzi d’umore, comportamenti anomali e cambiamenti di personalità. I pazienti tendono a passare facilmente dall’euforia alla depressione, a diventare irritabili e/o impulsivi, a farsi più agitati e ansiosi ecc.
- Difficoltà di linguaggio. Queste comprendono l’incapacità di terminare le conversazioni e di chiamare gli oggetti con i nomi corretti, la tendenza a ripetere le frasi pronunciate da altri, l’uso di un vocabolario ridotto e di un numero limitato di frasi.
- Problemi visivi. Tra questi, si ricordano le difficoltà a leggere, a quantificare la distanza degli oggetti e a determinare esattamente i colori. Inoltre, in demenze come il morbo di Alzheimer, insorge un disturbo curioso, per cui i pazienti, guardandosi allo specchio, non si riconoscono.
- Confusione (o disorientamento) spazio-temporale. I dementi in questo stato faticano (o non riescono proprio) a realizzare dove si trovano, che giorno della settimana è o qual è la stagione in corso. Inoltre, sono spesso disorientati, per cui ignorano il motivo per cui si siano recati in un certo posto.
- Riduzione o perdita delle capacità di giudizio. Ciò comporta, in molti malati di demenza, un calo dei freni inibitori, la tendenza ad agire in maniera errata o anomala (per esempio fanno spese inutili e/o assumono atteggiamenti inappropriati in pubblico), un certo disinteresse verso la propria igiene personale ecc.
- Problemi di equilibrio e/o di movimento
- Attacchi di agitazione e allucinazioni
EVOLUZIONE DELLE DEMENZE
Come si è detto, molte demenze hanno un andamento progressivo: cominciano con una lieve sintomatologia e, nel giro di un tempo più o meno lungo, portano a un marcato deterioramento delle capacità cognitive.
La morte per demenza sopraggiunge molto spesso per una complicazione legata alla demenza stessa. Per esempio, agli stadi finali, il morbo di Alzheimer determina delle gravi difficoltà di deglutizione, che a loro volta conducono allo sviluppo di ricorrenti polmoniti da inalazione e a gravi problemi di nutrizione.
DURATA DEL DECLINO
La durata del declino cognitivo è diversa da demenza a demenza.
Per esempio, il morbo di Alzheimer impiega di solito 7-10 anni per pregiudicare in maniera completa le facoltà cognitive; dopodiché causa la morte.
La demenza vascolare o quella frontotemporale, invece, agiscono differentemente da paziente a paziente: ci sono casi in cui la neurodegenerazione procede molto lentamente e casi in cui il deterioramento delle cellule nervose è molto rapido.
Farmaci
Eliminare o limitare i farmaci attivi sul sistema nervoso centrale spesso migliora la funzionalità. Devono essere evitati i farmaci sedativi e gli anticolinergici che tendono a peggiorare la demenza.
Gli inibitori delle colinesterasi, donepezil, rivastigmina e galantamina sono in qualche modo efficaci nel migliorare le funzioni cognitive nei pazienti affetti da malattia di Alzheimer o demenza con corpi di Lewy e possono essere utili in altre forme di demenza. Questi farmaci inibiscono l’acetilcolinesterasi, incrementando i livelli cerebrali di acetilcolina.
La memantina, antagonista dei recettori N-metil-d-aspartato, può aiutare a rallentare la perdita della funzione cognitiva nei pazienti con forma di demenza moderata e grave e può essere sinergico in associazione con un inibitore della colinesterasi.
I farmaci per il controllo disturbi del comportamento (antipsicotici) sono stati utilizzati.
I pazienti con demenza e segni di depressione devono essere trattati con antidepressivi privi di attività anticolinergica, preferibilmente gli inibitori della ricaptazione della serotonina.
Assistenza della persona che assiste il paziente (caregiver)
I familiari più prossimi di un paziente affetto da demenza sono i più coinvolti nella gestione delle loro cure. Gli infermieri e gli assistenti sociali possono insegnare loro e alle altre persone che assistono il paziente come soddisfare al meglio le necessità del paziente; l’insegnamento deve essere continuo. Sono disponibili supporti di altro tipo (gruppi di sostegno, materiale educativo, siti Internet).
Le persone che assistono il paziente possono andare incontro a uno stress importante. Lo stress può essere causato dalla preoccupazione su come proteggere il paziente e dalla frustrazione, stanchezza, rabbia e risentimento nel dover prestare così tante cure a qualcuno. Le figure professionali devono osservare gli eventuali sintomi precoci di stress ed esaurimento psicofisico della persona che assiste il paziente e, qualora fosse necessario, indicare servizi di supporto (assistente sociale, nutrizionista, infermiere, assistente domiciliare).
Se un paziente con demenza presenta una lesione insolita, deve essere indagata la possibilità di condizioni di maltrattamento dell’anziano.
Problematiche di fine vita
Poiché la percezione di sé e la capacità di giudizio si riducono nel tempo, nei pazienti con demenza può essere necessario affidare la gestione finanziaria a un membro della famiglia, un tutore oppure un avvocato. Nelle fasi precoci della demenza, prima che il paziente diventi totalmente incapace, è necessario che vengano chiariti i desideri del paziente circa il tipo di cure a cui vorrà essere sottoposto e la gestione di aspetti legali (disposizioni testamentarie, disposizioni relative alle cure mediche). Quando questi documenti sono firmati, deve essere valutata la capacità decisionale del paziente e devono essere registrati i risultati della valutazione. Sarebbe opportuno che venissero prese in anticipo, prima cioè, che se ne verifichi la necessità, le decisioni circa l’uso di alimentazione artificiale e trattamento delle malattie acute.
Nella demenza avanzata potrebbero essere più adatte misure palliative rispetto ad interventi altamente aggressivi o cure ospedaliere.