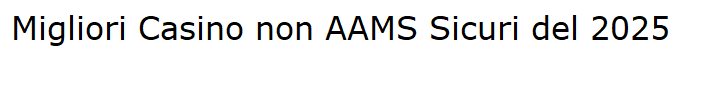La sera del 5 novembre 1956 è fredda e buia. Nel convento dei cappuccini di Mazzarino, paese agricolo in provincia di Caltanissetta, i frati sono chiusi nelle proprie celle a leggere e studiare, quando il silenzio è rotto dall’esplosione di due colpi di arma da fuoco e dalle grida di frate Agrippino.
Tutti gli altri frati accorrono e lo trovano steso a terra, fortunatamente illeso ma in stato di choc: non sa spiegare cosa sia successo, ha semplicemente visto la porta aprirsi leggermente, la canna di un fucile infilarsi nell’apertura e quindi gli spari lo hanno stordito.
I frati cercano di chiamare al telefono i carabinieri: ma il filo è stato tagliato, e fino all’indomani mattina nessuno ha il coraggio di andare in paese a fare la denuncia.
Il mistero comincia a dipanarsi
Qualche giorno dopo Carmelo Lo Bartolo, un uomo che da una decina d’anni coltiva l’orto del convento e gode della fiducia dei cappuccini, si avvicina a frate Agrippino e gli dice di avere saputo chi ha esploso i due colpi: una vera e propria banda di malviventi. “È mala gente”, aggiunge l’ortolano, “disposta a tutto. Sono molti e vogliono qualcosa… almeno settantamila lire”.
“E io dove le prendo?” risponde preoccupato il religioso, sapendo che tutto il denaro liquido del monastero nasceva dalle elemosine di una zona tutt’altro che ricca.
“Bisogna trovarle”, sentenzia l’ortolano allontanandosi, “perché è gente che non perdona”.
Annuncio pubblicitario
Interessato all'Intelligenza Artificiale?
Prova a leggere su Amazon Unlimited la nostra guida su come installarne una in locale e come ricavarne il massimo.
Una Intelligenza Artificiale locale ti permette di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'uso dell'IA ma senza dover pagare costosi abbonamenti.
📘 Leggi la guida su AmazonLo stesso discorso viene fatto ad altri frati e tutti, chiedendo alle proprie famiglie e arrangiandosi alla meglio, cominciano a versare in varie riprese nelle mani dell’astuto Lo Bartolo somme di denaro per l’ammontare complessivo di oltre un milione di lire.
Prime richieste
I frati sono ormai in uno stato di terrore, abilmente alimentato dal Lo Bartolo. Un giorno l’ortolano, sempre dicendo di essere stato avvicinato dai banditi, riferisce che gli stessi volevano estorcere del denaro a un notabile del luogo, il dottor Ernesto Colajanni, proprietario di una farmacia. “È desiderio della banda”, aggiunge Lo Bartolo, “che due monaci si rechino dal dottor Colajanni e si facciano consegnare due milioni in biglietti da diecimila lire. Fate attenzione e dite al medico che, se non pagherà subito, la banda rapirà il suo bambino”.

Dopo diversi giorni di angosciosa incertezza, sempre incalzati dalle minacce del Lo Bartolo, frate Agrippino e un altro si recano in casa del dottor Colajanni, che rifiuta di cedere alle pretese dei banditi. Era il 2 marzo del 1957. Quindici giorni dopo, nottetempo, un incendio viene appiccato alla farmacia.
“Soltanto la mattina dopo”, racconterà in seguito l’anziano farmacista, “quando tornarono i monaci per dirmi che si era trattato di una rappresaglia dei banditi, decisi, per non correre altri rischi, di anticipare un milione. Eravamo certi che i banditi ci avrebbero lasciati in pace: ma non fu così. Esattamente un anno dopo tornarono alla carica con una lettera nella quale era scritto “di consegnare a chi lei sa” il denaro richiesto. Fummo proprio noi stavolta a chiamare i frati, ai quali consegnammo mezzo milione. Dopo circa dieci giorni mi giunse un’altra lettera, nella quale era scritto che se volevo vivere tranquillo dovevo saldare il conto. E fu così che, proprio nel giorno di giovedì santo dell’anno scorso, consegnai ai cappuccini altre cinquecentomila lire”.
Si arriva all’omicidio
Ma l’attenzione dei banditi non è polarizzata tutta sul dottor Colajanni. Le lettere, contenenti gravi minacce, cominciano a pervenire anche ad altri possidenti della zona, tra cui Angelo Cannada, che alle richieste dei frati risponde di “confidare nella protezione di Dio”. Un giorno, mentre insieme a moglie e figlio si trova in auto, è costretto a fermarsi perché la strada è sbarrata. Improvvisamente compaiono alcuni uomini mascherati i quali lo trascinano a viva forza sotto un ulivo e lo uccidono sotto gli occhi della sua famiglia.
Non contenti, i banditi fanno pervenire alla vedova Cannada una nuova richiesta: ben dieci milioni, altrimenti anche il figlio farà la stessa fine. E’ l’ottantenne frate Carmelo a condurre la trattativa, riuscendo ad ottenere un considerevole sconto: alla fine vennero versati “solamente” tre milioni, pagabili in sei rate.
Dopo tale episodio nessuno a Mazzarino osa più sfidare la gang, ed il “lavoro” per i frati cresce notevolmente. E perché le richieste siano evase con prontezza non si manca di uccidere qualche bovino o di bruciare del frumento per rappresaglia.
Frati estorsori: cominciano le indagini
La vedova Cannada, intanto, aveva denunciato ai carabinieri le malefatte subite, accusando senza mezzi termini i frati del convento come complici dei banditi.
I carabinieri iniziano le indagini e fanno una perquisizione nel convento: nel giardino viene trovata, sepolta, la macchina con la quale erano state scritte le lettere anonime, inoltre nella stanza del Lo Bartolo è nascosta una carabina a canna corta compatibile con quella che ha ucciso il Cannada. L’ortolano, nel frattempo, è fuggito a Genova presso un parente e viene arrestato proprio mentre sta trattando l’acquisto di una villa: rinchiuso nel carcere di Caltanissetta, si impicca nella sua cella.
Vengono anche arrestati tre giovani mazzarinesi, con l’accusa di essere gli esecutori materiali dell’omicidio Cannada, ed infine il 16 febbraio del 1960 la polizia arresta quattro frati con gravi accuse: estorsioni, lettere minatorie, omicidio, ferimenti. Non che i quattro monaci ne siano materialmente gli autori, ma secondo la polizia avevano gravi responsabilità in ordine a questi reati.

Padre Vittorio, guardiano del monastero (al secolo Ugo Bonvissuto, di 40 anni, da Gela), frate Carmelo (Luigi Galizia, di 81 anni, da Mazzarino), frate Agrippino (Antonio Ialuna, di 35 anni, da Mineo) e frate Benanzio (Liborio Marotta, di 36 anni, da Mazzarino), vengono tradotti al carcere di Caltanissetta.
Inizia il processo
Il processo si apre a Caltanissetta. I difensori sperano che il giudice assolva i loro assistiti o che almeno ne distingua le responsabilità da quelle dei laici, e il principale difensore, il cattolicissimo Giuseppe Alessi ottiene il trasferimento del processo per legittima suspicione: sui banchi dell’accusa siederebbero «avvocati leader politici dell’anticlericalismo e dei partiti di sinistra».
Ci si trasferisce quindi a Messina. I frati raccontano di avere agito a fin di bene e di non avere mai intascato una lira delle somme riscosse, consegnate ogni volta al Lo Bartolo. Perché, si chiede l’accusa, i frati non hanno denunciato i fatti ai carabinieri? Perché non si sono confidati con i loro superiori, chiedendo un trasferimento che certamente gli sarebbe stato garantito? Inoltre, erano molto zelanti nel sollecitare il pagamento delle somme e ogni volta si assicuravano che le vittime non annotassero i numeri delle banconote. La loro partecipazione psicologica ai delitti è quindi stata «piena», e se si considera l’ascendente di cui godevano e il grado di cultura rispetto ai complici, non c’è dubbio: sono loro «i capi dell’associazione a delinquere», secondo la durissima requisitoria del Pubblico Ministero.
Secondo il collegio di difesa, invece, la mente sarebbe stata il Lo Bartolo, vero capo della banda che coi frati recitava la parte del protettore. I monaci sarebbero stati testimoni, non coimputati.
Sentenze contraddittorie
La sentenza di primo grado di Messina assolve i frati per avere agito in «stato di necessità», e loro vengono scarcerati. Ma dopo un anno il verdetto viene riformato dalla Corte d’Assise di Messina, che condanna i frati a 13 anni. Due anni dopo, la sentenza viene annullata per difetto di motivazione, e si apre a Perugia un nuovo processo d’appello; la pena viene ridotta da 13 a 8 anni ma la correità dei frati viene riaffermata. Saranno solo in tre a scontare la condanna: frate Carmelo, il più anziano, muore nel dicembre 1964.
Su questo caso, nel 2012, il regista Salvo Bonaffini ha girato un film: Pagate fratelli.
https://www.malgradotuttoweb.it/la-storia-dei-frati-di-mazzarino-tra-estorsioni-e-vendette/